 |
Il Miglio verde israeliano: quando la pena di morte diventa progetto politico
di Emma Buonvino
C’è qualcosa di profondamente inquietante in quello che sta accadendo in questi giorni dentro il sistema carcerario israeliano.
Non stiamo parlando di un dibattito teorico.
Non di un confronto giuridico.
Non di un passaggio parlamentare qualunque.
Stiamo parlando della preparazione concreta di una macchina della morte.
La proposta di legge sulla pena di morte — passata in prima lettura alla Knesset — viene presentata come misura contro il “terrorismo”. Ma nella realtà politica e giudiziaria israeliana, quella parola ha un significato quasi esclusivo: palestinesi.
Intanto, mentre il testo legislativo deve ancora completare il suo iter, si costruiscono strutture. Si organizzano corsi di “formazione psicologica” per i futuri boia. Si parla di impiccagione. Si pianificano viaggi studio in Asia orientale per osservare come altri Stati applicano la pena capitale.
Non è deterrenza.
È premeditazione.
Secondo le notizie riportate da Channel 13 News, si progetta una struttura sul modello del “Green Mile” americano. Un corridoio della morte israeliano. Tre esecutori volontari per ogni impiccagione, così da “distribuire la responsabilità”.
Distribuire la responsabilità.
Come se frammentare il gesto potesse alleggerire la colpa.
Il ministro Ben Gvir non nasconde l’entusiasmo. Parla di giustizia. Parla di forza. Parla di necessità.
Ma uno Stato che introduce la pena di morte in un contesto di occupazione militare prolungata, tribunali militari per una sola parte della popolazione, detenzione amministrativa senza processo e sistematica disparità giuridica, non sta rafforzando la giustizia.
Sta codificando la vendetta.
Nel diritto internazionale contemporaneo la tendenza è chiara: abolizione. Moratoria. Riduzione. Perché la pena di morte non è solo una punizione estrema: è l’ammissione che lo Stato rinuncia alla possibilità di essere migliore del crimine che condanna.
E qui c’è un ulteriore abisso: l’applicazione selettiva.
Se una legge nasce per colpire quasi esclusivamente un gruppo etnico o nazionale, non è giustizia. È discriminazione istituzionalizzata.
Un “miglio verde” costruito mentre Gaza è stata devastata, mentre la Cisgiordania brucia, mentre migliaia di palestinesi sono detenuti, molti senza processo.
Non è sicurezza. È un salto di qualità nell’architettura del dominio.
La storia insegna che quando uno Stato normalizza l’eliminazione legale del nemico, il confine tra diritto e vendetta si dissolve rapidamente. E quando l’esecuzione diventa routine amministrativa, la disumanizzazione è già compiuta.
Non si tratta di difendere Hamas.
Si tratta di difendere un principio universale: il diritto alla vita non può essere sospeso per appartenenza nazionale.
Costruire una camera di impiccagione mentre il conflitto è ancora aperto significa scegliere la strada dell’irreversibilità.
E l’irreversibilità, in un sistema già segnato da profonde asimmetrie di potere, non è giustizia.
È condanna collettiva travestita da legalità.
Questo non è un passaggio tecnico.
È una svolta morale.
E quando la morte entra nel codice penale con un bersaglio preciso, il problema non è solo chi verrà impiccato.
È che l’intera società si abitua all’idea che alcune vite siano sacrificabili.
VAI A TUTTE LE NOTIZIE SU GAZA
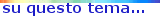 
Dossier
diritti
|
|

