 |
Iran: giustizia, martirio e potere nella storia del paese
di Leandro Leggeri
Le recenti proteste in Iran hanno riportato al centro del dibattito non solo la crisi economica e sociale del Paese, ma anche una questione più profonda e spesso fraintesa: il rapporto tra sciismo, potere politico e legittimità dell’autorità. Nel discorso mediatico occidentale, lo sciismo viene spesso ridotto a una variante “integralista” dell’Islam, oppure identificato senza mediazioni con la Repubblica Islamica iraniana.
In realtà, la dottrina sciita – in particolare nella sua forma duodecimana o imamita – nasce come visione religiosa della giustizia, del martirio e dell’opposizione all’oppressione, e contiene al suo interno una tensione strutturale tra attesa escatologica, rivolta morale e rapporto con il potere.
Comprendere lo sciismo significa capire il terreno simbolico, religioso e storico su cui il sistema politico iraniano si è costruito e sul quale oggi viene anche contestato. Le proteste attuali mostrano con chiarezza questa frattura: da un lato uno Stato che rivendica la propria legittimità in nome dello sciismo; dall’altro settori della società che, pur muovendosi spesso su rivendicazioni economiche e sociali, si collocano implicitamente dentro una tradizione sciita di rifiuto dell’ingiustizia e dell’arbitrio del potere.
È in questo contesto che una rapida ricostruzione della dottrina dello sciismo diventa necessaria: non come esercizio accademico, ma come strumento per comprendere le ambiguità, le contraddizioni e le possibilità ancora aperte all’interno della società iraniana. Ci concentreremo sullo sciismo duodecimano o imamita, in quanto corrente maggioritaria in Iran e matrice religiosa e simbolica del sistema politico vigente, tralasciando altre ramificazioni minoritarie come ismailismo, zaydismo o alawismo.
La divisione tra sunniti e sciiti nasce immediatamente dopo la morte del Profeta Muhammad nel 632 d.C. e riguarda una questione tutt’altro che secondaria: chi ha il diritto di guidare la comunità dei credenti (umma) e su quale base.
Per quella che diventerà la maggioranza sunnita, il Profeta non avrebbe designato un successore specifico; la guida della comunità doveva quindi essere scelta attraverso il consenso dei notabili. Da qui nasce l’istituto del Califfato (khalīfa, “vicario”), inteso come autorità politica e amministrativa, priva di infallibilità religiosa. Il califfo sunnita non è depositario di una verità rivelata: governa, amministra, applica la legge, ma non la interpreta in modo vincolante sul piano spirituale.
Una minoranza, invece, sostenne che Muhammad avesse indicato esplicitamente come suo successore ʿAlī ibn Abī Ṭālib, cugino e genero del Profeta, durante il celebre sermone di Ghadīr Khumm. Da questa posizione nasce la shīʿat ʿAlī, il “partito di Alì”, da cui il termine sciiti. Per gli sciiti, la guida della comunità non può essere frutto di un’elezione o di un compromesso politico: l’autorità autentica è di origine divina e si trasmette per designazione (naṣṣ), non per consenso.
Qui si apre una divergenza strutturale che attraversa tutta la storia islamica.
Nel sunnismo, potere temporale e autorità religiosa restano distinti; nello sciismo, essi tendono a coincidere nella figura dell’Imam, che non è solo un governante, ma il custode di una conoscenza superiore, esoterica, capace di “aprire” il senso profondo della Rivelazione.
Nello sciismo duodecimano o imamita, l’Imam non è semplicemente un capo politico. È maʿṣūm, cioè protetto dall’errore nel campo della fede, e detiene un sapere che non si esaurisce nella legge esteriore (sharīʿa), ma ne rivela il significato interiore.
Nel sunnismo l’interpretazione della legge, la guida spirituale e l’amministrazione del potere restano ambiti separati e affidati a soggetti diversi; nello sciismo imamita, queste funzioni convergono nell’Imam, che non è solo un giurista o un capo politico, ma il depositario di un’autorità religiosa totale, fondata su una legittimazione divina.
Come ha osservato Henry Corbin, con la fine della profezia non si chiude la possibilità della conoscenza religiosa, ma si apre un nuovo ciclo: al tempo della profezia (daʾirat al-nubuwwa) succede il tempo della walāya, l’autorità spirituale degli Imam. La walāya non è solo santità o devozione, ma potere di guida, legittimità e orientamento della comunità verso la giustizia.
Questo punto è cruciale per capire lo sciismo come tradizione potenzialmente sovversiva: se l’autorità è legittima solo quando incarna la giustizia divina, ogni potere ingiusto è, per definizione, illegittimo, anche se formalmente “islamico”.
Secondo lo sciismo imamita, i legittimi successori del Profeta sono dodici Imam, tutti discendenti di ʿAlī ibn Abī Ṭālib e di sua moglie Fāṭima, figlia di Muḥammad: ʿAlī, al-Ḥasan, al-Ḥusayn, ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, Muḥammad al-Bāqir, Jaʿfar al-Ṣādiq, Mūsā al-Kāẓim, ʿAlī al-Riḍā, Muḥammad al-Jawād, ʿAlī al-Hādī, al-Ḥasan al-ʿAskarī e infine Muḥammad ibn al-Ḥasan, noto come al-Mahdī.
Con la scomparsa del dodicesimo Imam, Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Mahdī, nel 874 d.C., ebbe inizio una fase detta dell’Occultamento Minore (ghayba al-ṣughrā), durante la quale l’Imam nascosto mantenne un contatto indiretto con la comunità sciita attraverso quattro successivi nāʾib (rappresentanti). Questo periodo durò circa settant’anni. Alla morte dell’ultimo di essi, ʿAlī ibn Muḥammad al-Samarī, l’Imam annunciò, tramite una lettera, che non vi sarebbe stato alcun ulteriore rappresentante, dando così inizio al Grande Occultamento (ghayba al-kubrā), che perdura tuttora.
L’Imam non è morto, ma nascosto: tornerà alla fine dei tempi per ristabilire la giustizia. Questo elemento introduce una tensione permanente nella dottrina sciita: vivere in un mondo ingiusto, sapendo che il potere legittimo è assente, e che ogni ordine politico è, in qualche misura, provvisorio e imperfetto.
Da questo vuoto di autorità nasce una duplice possibilità storica e teologica: da un lato una lettura quietista, che interpreta l’Occultamento come un tempo di attesa, prudenza e sopportazione dell’ingiustizia in vista del ritorno dell’Imam; dall’altro una lettura attivista, che considera invece la lotta contro l’oppressione e l’ingiustizia come una forma di preparazione storica e morale al suo avvento. Questa ambivalenza attraversa tutta la storia sciita e riemergerà con forza nel Novecento iraniano.
Il momento fondativo dell’immaginario sciita è il martirio del terzo Imam, Ḥusayn ibn ʿAlī, ucciso a Karbala nel 680 d.C. dalle truppe del califfo omayyade Yazīd. Karbala non è solo un episodio storico, ma un paradigma permanente: il conflitto asimmetrico tra giustizia e potere, tra legittimità morale e dominio politico. Ḥusayn non combatte per vincere militarmente, ma per testimoniare un principio: l’illegittimità di un potere fondato sull’arbitrio, sulla corruzione e sulla violenza.
La sua scelta di non sottomettersi, pur sapendo di andare incontro alla morte, imprime allo sciismo una dimensione etica radicale. Il martirio (shahādat) non è ricerca della morte, ma rifiuto del compromesso con l’ingiustizia. In questo senso, Karbala diventa una grammatica politica: ogni tempo può essere Karbala, ogni potere ingiusto può essere Yazīd, ogni comunità oppressa può riconoscersi nel campo di Ḥusayn.
È qui che si forma la specificità sciita del rapporto tra religione e politica.
La memoria di Karbala non produce fatalismo, ma una tensione permanente tra attesa escatologica e responsabilità storica. La commemorazione dell’ʿĀshūrāʾ non è solo lutto rituale, ma rinnovamento di un patto morale: stare dalla parte degli oppressi (mustadʿafīn) contro gli oppressori (mustakbirīn).
Questa dimensione ha attraversato i secoli, riemergendo con forza nell’Iran contemporaneo. Nel Novecento, pensatori come ʿAlī Shariʿati hanno riletto Karbala in chiave anticoloniale e sociale, contrapponendo uno sciismo “rosso”, militante e liberatore, a uno sciismo “nero”, ridotto a ritualismo passivo e funzionale al potere. Questa rilettura influenzerà profondamente la Rivoluzione del 1979, in cui il linguaggio del martirio, della resistenza e della giustizia sociale verrà tradotto in progetto politico.
Su questo terreno simbolico e politico si innesta l’elaborazione di Ruhollah Khomeini. La dottrina della velāyat-e faqīh nasce come risposta a una domanda concreta: come tradurre, nell’epoca dell’Occultamento dell’Imam, quella tensione etica tra giustizia e potere che Karbalā ha inscritto nello sciismo.
Per Khomeini, limitarsi all’attesa passiva del Mahdī significa tradire lo spirito di Ḥusayn; al contrario, l’assenza dell’Imam impone una responsabilità storica. Da qui l’idea che, in mancanza della guida infallibile, il compito di governare spetti ai giurisperiti sciiti (fuqahāʾ), in quanto depositari della legge e chiamati a difendere gli oppressi contro gli oppressori.
La velāyat-e faqīh non nasce dunque come semplice giustificazione teocratica del potere, ma come tentativo di politicizzare l’eredità di Karbalā: impedire che l’ingiustizia si riproduca dietro la maschera dell’ordine, e che la religione venga relegata a ritualismo innocuo. Nella sua formulazione originaria, essa intende colmare il vuoto tra attesa escatologica e azione storica, trasformando la memoria del martirio in principio di governo.
È solo nel passaggio dalla teoria alla pratica statale, dopo il 1979, che questa dottrina assume una forma centralizzata e istituzionale, cristallizzandosi in un sistema di potere permanente. Ma il suo nucleo ideologico affonda precisamente in quella grammatica politica di Karbalā: l’idea che la neutralità di fronte all’ingiustizia non sia un’opzione legittima, e che la responsabilità ricada su chi ha gli strumenti per esercitare l’autorità.
A conclusione, lo sciismo imamita rivela una tensione storica e politica costitutiva. Nato come visione della giustizia, della testimonianza e del rifiuto dell’oppressione, ha prodotto nel tempo un immaginario profondamente critico dell’ordine costituito, capace di parlare agli esclusi, ai poveri e ai vinti della storia. Karbalā non è soltanto un evento del passato, ma una grammatica morale permanente che rende ogni potere giudicabile e ogni ordine revocabile di fronte all’ingiustizia.
La Rivoluzione del 1979 ha rappresentato il tentativo più radicale di tradurre questa eredità in forma statale. Una volta divenuto Stato, però, lo sciismo politico si è trovato di fronte a una contraddizione strutturale: come istituzionalizzare una tradizione nata contro il potere senza snaturarne il nucleo etico. Nella concezione di Khomeyni, la velāyat-e faqīh legittima l’esercizio dell’autorità dell’Imam occulto da parte dei giurisperiti fino al suo ritorno; la sua traduzione in architettura statale ha tuttavia finito per cristallizzare questa dottrina in una sovranità permanente, attenuandone la funzione critica originaria.
Ne deriva un paradosso che attraversa l’Iran contemporaneo: lo stesso linguaggio della giustizia, del martirio e della difesa degli oppressi può essere mobilitato tanto per contestare l’ordine quanto per legittimarlo. La memoria di Karbalā continua a essere evocata, ma il suo significato resta conteso: è richiamo alla responsabilità morale contro l’ingiustizia o fondamento simbolico di un potere che teme la messa in discussione?
È in questa frattura che si collocano molte delle tensioni attuali. Le proteste sociali, le rivendicazioni economiche, le critiche politiche non si muovono in un vuoto ideologico, ma dentro un orizzonte simbolico che il potere stesso ha contribuito a costruire. Comprendere lo sciismo imamita significa allora comprendere non solo una dottrina religiosa, ma un campo di conflitto: tra attesa e azione, tra giustizia e ordine, tra rivoluzione e Stato.
È in questo spazio, ancora aperto, che si gioca il futuro della Repubblica Islamica e delle sue possibilità di trasformazione.
VAI A TUTTE LE NOTIZIE SU GAZA
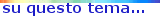 
Dossier
diritti
|
|

