 |
Testimonianza di Rami, scampato a Sde Teiman
di Samir Al Qaryouti
L'autobus... quando la strada diventa una punizione
Tra le scene più dure della detenzione che non abbandonano la mia memoria, ci sono le operazioni di trasferimento in autobus tra le sezioni del centro di detenzione di Sde Teiman. Scene che non somigliano a uno spostamento da un luogo all’altro, ma piuttosto a una traversata ripetuta in un lembo di inferno a cielo aperto.
Sde Teiman non è un semplice centro di detenzione; è uno spazio al di fuori di ogni legge. La differenza tra questo luogo e le prigioni più oscure del mondo è quasi nulla. Situato tra Beersheba e Gaza e gestito direttamente dall’esercito, senza supervisione né regole chiare, sembra che l’unico scopo della sua esistenza sia spezzare l’essere umano palestinese proveniente da Gaza. Le sezioni sono vicinissime tra loro, separate solo da uno o due minuti; sentivamo le voci degli uni e degli altri e percepivamo la nostra vicinanza... ma ciò che veniva praticato durante il trasporto era l’opposto di questa prossimità.
Durante i miei tre mesi in questo centro, sono stato trasferito più di quindici volte tra diverse sezioni. In alcune sono tornato due o tre volte, come se il girare a vuoto fosse di per sé parte della punizione. Il processo di trasferimento iniziava sempre allo stesso modo: mani legate dietro la schiena con una stretta dolorosa, piedi incatenati e occhi bendati. Poi il corpo veniva trascinato con forza, senza domande né indugi, fino all’autobus.
L’autobus, che poteva ospitare decine di persone, non era un mezzo di trasporto, ma una cella di punizione mobile. Il detenuto veniva costretto a sedersi con la testa china, senza vedere nulla, potendo solo ascoltare e sentire il peso del tempo che passava. Non appena la porta si chiudeva, iniziava un altro capitolo: la presenza dei soldati all’interno non era per sorveglianza, ma per praticare violenze deliberate, come se la strada fosse stata creata per essere un palcoscenico per tali abusi.
Una volta chiuse le porte, il significato del mezzo cambiava completamente. Non era più un trasporto, ma uno spazio chiuso dove la crudeltà veniva amministrata con piena consapevolezza. All’interno, i soldati si muovevano tra i sedili, osservando i corpi legati e le teste chine, come se stessero ispezionando un campo privo di qualsiasi diritto o dignità.
La tortura lì era metodica e deliberata. Ci veniva imposto di sedere in posizioni estenuanti, con la testa abbassata per tutto il tempo, e ogni movimento — anche solo per riprendere fiato — veniva accolto con urla e minacce. I soli suoni bastavano a confondere la percezione del tempo: ordini incessanti, insulti deliberati con le parole più volgari e rumori intenzionali per seminare il terrore e tenere i nervi tesi.
Venivamo colpiti con scariche elettriche come mezzo di sottomissione improvvisa, per il solo scopo di distruggere ogni senso di sicurezza. Insieme ai colpi ripetuti in punti scelti del corpo, specialmente sul torace — chi di noi non ha avuto le costole rotte più volte? — le percosse venivano inflitte rapidamente per poi fermarsi di colpo e ricominciare, come se l'obiettivo fosse mantenere il detenuto in uno stato di perenne attesa e ansia.
Nessuno veniva risparmiato. Né anziani, né giovani, né malati. Eravamo tutti uguali dentro quell'autobus: non eravamo visti come individui, ma come numeri. Era chiaro che allungare il percorso facesse parte della scena; la breve distanza si trasformava in un lungo giro, solo per prolungare il tempo dell'umiliazione e trasformare l'attesa stessa in uno strumento di tortura.
In quei momenti, non era solo il dolore a essere crudele, ma la sensazione che ciò che accadeva avvenisse senza fretta e senza timore di doverne rendere conto. Come se il tempo dentro l'autobus fosse sospeso, senza fine, finché loro non decidevano di aprire la porta e gettare il corpo in una nuova stazione di tormento.
Un tragitto che non richiederebbe più di pochi minuti si estendeva per oltre mezz'ora. Non ci muovevamo verso una destinazione chiara; giravamo in tondo, solo per far passare il tempo, solo per completare la scena. Era evidente che l'obiettivo non fosse arrivare, ma godere nel prolungare quel momento.
In un'occasione, il trasferimento era verso Gerusalemme. Il viaggio per arrivarci richiede solitamente poche ore, ma durò più di sei ore. Non era la strada a essere più lunga... era la crudeltà a decidere il tempo. Ore di percosse, torture, insulti verbali, tentativi di spezzare il morale e di schiacciare ciò che restava dell'umanità del detenuto, mentre era bendato, incatenato e senza altra risorsa che il silenzio.
Questa non è una storia isolata, ma un modello ripetitivo. Scene dell'inferno di Sde Teiman che i prigionieri di Gaza conoscono bene e di cui condividono il dolore senza previo accordo. Dettagli indimenticabili, non perché accaduti una volta, ma perché ripetuti fino a diventare una prova quotidiana di pazienza e sopravvivenza.
Eppure, nonostante tutta questa oscurità, una cosa è rimasta impossibile da spezzare: la memoria. Una memoria che custodisce la testimonianza e mantiene viva la storia, per dire che ciò che è accaduto non è stato passeggero e che il dolore che abbiamo vissuto non è rimasto senza testimoni.
Tra le mura del centro di detenzione israeliano di #Sde_Teiman …. L’inferno
Ricordo ancora quei giorni in cui la fame era parte dell'aria che respiravamo. Ciò che l'occupazione ci offriva non superava un cucchiaio di yogurt o di marmellata, come se volessero testare la capacità dell'essere umano di resistere con il minimo indispensabile. Quanto a quel cucchiaio di tonno che vedevamo ogni una o due settimane, per me era come un evento eccezionale, una piccola finestra affacciata su un mondo normale che stavo dimenticando a poco a poco.
Il carceriere conosceva bene la nostra bramosia per quel boccone... per questo lo rovinavano deliberatamente, lavandolo con acqua e sapone finché il sapore non cambiava. Allungavo la mano incatenata verso di esso sapendo che non era più il tonno che conoscevo un tempo, ma nonostante ciò significava una cosa sola: che ero ancora vivo, e che dentro di me c'era uno spazio che ancora si aggrappava alla vita nonostante tutto.
Quei momenti erano crudeli, non solo perché il boccone era amaro, ma perché veniva servito con una dose di umiliazione che cercava di trafiggerti l'anima. Eppure, lo ingoiavo... non per saziarmi, ma per dire a me stesso che ero più forte dei loro tentativi, e che la mia dignità era più grande delle catene alle mie mani e più profonda della benda sui miei occhi.
Questi piccoli dettagli, con tutto il dolore e la pazienza che portano con sé, vivono ancora dentro di me. Non mi ricordano la mia debolezza...
Rami Abu Zubaeda
Gaza
VAI A TUTTE LE NOTIZIE SU GAZA
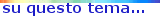 
Dossier
diritti
|
|

