 |
La patria di Richard
di
Rinaldo Battaglia *
“La Patria di un uomo non è il luogo dov'è nato, ma quello dove cessano i suoi tentativi di fuggire”.
Sono parole di un nobel, il poeta/scrittore egiziano Najib Mahfuz (Nobel per la letteratura nel 1988) che mi hanno sempre colpito e talvolta confuso. E farlo in qesti giorni che ricordano il 4 novembre 1918, quando finì per noi la Prima Guerra Mondiale, dove oltre 650 mila militari italiani persero la vita, potrebbe essere fuorviante se non controcorrente. Perché loro sono morti per la patria o, con altri, mandati a uccidere per non essere uccisi in nome della patria. Talvolta anche contro i propri fratelli di sangue.
Mi ricordo quando visitai il museo di Vermiglio, verso Trento, di alcune lettere che due fratelli spedirono alla loro madre: uno combatteva per l’Austria, l’altro per l’Italia. Ed entambe risultavano piene di calore verso la loro famiglia e disprezzo verso la guerra. Ma mai una parola contro la loro divisa o la loro patria o quella per cui loro, in quel momento, combattevano. Ed erano fratelli.
Del resto, se Patria significa ‘patriottismo’, servirebbe riportare una citazione di Tomáš Garrigue Masaryk, il primo Presidente della Repubblica Cecoslovacca, noto (per quei pochi che lo conoscono) come ‘il Presidente Liberatore’:
"Il patriottismo è amore per la propria nazione, non odio per gli altri.“
Quest’ultimo si chiama ‘nazionalismo’ ed è un veleno che giorno per giorno oggi cresce, tra l’indifferenza colpevole di troppi e il vantaggio di pochi.
Patria: cos’è quindi la Patria?
Cosa s’intende con questo termine per cui milioni di uomini si sono scannati e hanno scannato altri milioni di vite. Ieri, oggi e di certo anche domani.
Da vicentino non posso che riportare alla memoria altre parole di uno che ha conosciuto la guerra, la disfatta in Russia, i lager nazisti come IMI, l’antifascismo: Mario Rigoni Stern.
Semplice e toccanti quelle sue righe:
“Essere di casa, tra le cose, e nel mondo che vivi. Questa è patria”.
“La Patria di un uomo non è il luogo dov'è nato, ma quello dove cessano i suoi tentativi di fuggire”.
La Patria non è il luogo dove tu sei nato, ma dove tu trovi i valori su cui sei cresciuto e che consideri il tuo vangelo, la tua bussola per vivere in pace con la tua coscienza. La pietra angolare su cui vuoi costruire la tua casa.
Pochi anni fa, per il Giorno della Memoria 2020, alcuni giornali americani portarono alla notorietà il caso di ex-militare, sconosciuto al mondo fino allora e già deceduto ancora nel 1967. Il primo articolo comparve nel numero ‘Three Weeks del 2020’ di ‘The Jewish American Warrior’. Fu un suo nipote a parlarne allora, poi arrivò il giusto risalto tramite la stampa.
E – oggi - riprendo quel caso, perché la vita di quell’ex-soldato rappresenta al meglio, almeno per me, il concetto di ‘patria’ nel senso di ‘patriottismo’ non certo di ‘nazionalismo’.
Quel soldato di nome faceva Richard Stern. Era tedesco, periferia di Colonia, nato ai tempi del Kaiser e di Otto Eduard Leopold von Bismarck, colui che più di altri forgiò il concetto di superpotenza militare per la Germania. Quando nell’agosto 1914 la sua patria invase il Lussemburgo ed il Belgio con obiettivo Parigi.
Richard Stern si arruolò subito, giovanissimo, da ragazzo, come volontario in nome proprio della sua patria e per la vittoria della sua patria. Combatterà per il Kaiser per 4 lunghi anni, combatterà, ucciderà per non essere ucciso, vedrà i suoi commilitoni morire e soffrire prima di morire. Capirà il senso della parola ‘guerra’. Sarà presente in più battaglie e più luoghi, mostrerà coraggio ed eroismo tanto che gli venne conferita la prestigiosa Croce di Ferro. Una medaglia, un onore per lui, un vanto. A guerra finita ne parlerà con tutti e a tutti la mostrerà. Era il suo orgoglio, il suo biglietto da visita.
Anni dopo, quando Hitler nel marzo 1933 cercò eroi nascosti da esaltare per recuperare lo spirito della guerra, andato perduto dopo la sconfitta del novembre 1918, trovò anche il suo nome. E Richard Stern ricevette così dal Fuhrer persino la “Croce Anseatica per i suoi meriti in guerra”, uno dei pochi.
Altro vanto, altro onore per il soldato Richard.
Ma poi, poi le cose cambiarono maledettamente in fretta.
Perché se Hitler lo aveva premiato, non aveva tenuto conto che quel Richard Stern era un ebreo. Era sì tedesco, aveva onorato la sua patria, ma ora era diventato ‘razza inferiore’, spazzatura del mondo, rifiuto della società.
Eppure, tornato dalla guerra – assorbite le ferite fisiche e morali della sconfitta – Richard si era rifatto una vita, con tanto lavoro e tanto impegno. Aveva aperto ed avviato un negozio di biancheria e tessuti nella sua Colonia, aveva messo su famiglia, stimato ed onorato dai suoi concittadini. E non solo per la medaglia ricevuta. Ma cosa voleva dire tutto questo, quando il sano patriottismo diventa fanatico nazionalismo?
E così solo un mese dopo la ‘Croce Anseatica’, il 1° aprile 1933 quando i nazisti lanciarono il boicottaggio delle attività commerciali di proprietà ebraica – mandando soldati davanti ad ogni negozio di ebrei per sconsigliare i clienti ad entrare – anche Richard ne fu colpito. Ma quella era ancora la sua patria, il suo paese. Il luogo in cui era nato e per il quale aveva combattuto.
E così si fece fotografare davanti all’entrata del suo negozio, vicino ad una giovane guardia mandata lì per bloccare la sua attività, ben vestito e con tanto di ‘Croce di Ferro’ al petto. Perché lui era un tedesco che aveva lottato per la Germania ed era stato onorato, scelto, premiato. Lui era un veterano di guerra, un eroe. Non era ‘razza inferiore’, era un uomo e meritava rispetto. Come gli altri tedeschi – ebrei e non ebrei – che avevano combattuto sulla Somme, sulla Marna, a Verdun. Quella ‘Croce di Ferro’ sul petto era la sua sfida a chi aveva rubato la dignità e la libertà nel suo paese, nella sua patria. Era il 1° aprile 1933 e Richard non voleva cedere al nazismo. Era il nazismo, col suo criminale nazionalismo, ad avere calpestato il suo concetto di patria.
Lotterà anno su anno. Per sei anni tenne testa a tutto, ma quando la guerra era oramai alle porte e con minacce costanti ai suoi familiari (la sorella Martha e il figlio di lei, Rudolf di cui Richard era legalmente il tutore), si arrese. Quella non era più la sua patria. E decise di fuggire verso gli Usa.
Fu costretto a lasciare tutto, negozio, casa vestiti, beni personali. Tutto. Tutto regalato alla ‘Treuhandstelle’, l’ufficio fiduciario nazista che ti lasciava la vita dandoti in cambio solo un biglietto di espatrio se firmavi la cessione di tutti i tuoi beni al regime. Tutto regalato, tutto lasciato in Germania alla nuova Germania.
Ma tranne due cose. Richard Stern si tenne la sua ‘Croce di Ferro’ e la sua ‘Croce Anseatica’. Erano il suo orgoglio, il suo biglietto da visita, la sua dignità di uomo.
Arrivò con la famiglia così negli Usa, tra cento diffidenze e mille difficoltà: era tedesco, arrivava dal paese che stava attaccando e distruggendo l’Europa. Si fermò nel Queens, fece lavori anche umili, poi fu assunto come cameriere. E cercò di ripartire.
Ma poi anche negli Usa le cose cambiarono maledettamente. Arrivò Pearl Harbor, arrivò la guerra, arrivarono gli arruolamenti verso il Pacifico. E Richard Stern non volle restare alla finestra. Ma aveva 42 anni e non aveva ancora ottenuto la cittadinanza statunitense.
Insistette e dopo le battaglie di Guadalcanal, la fame di nuovi soldati da spedire al fronte modificò le carte in gioco. Richard il 13 ottobre 1942 venne così arruolato, come volontario nell'esercito americano.
E anche qui stesso copione del film precedente. Combatterà con la divisa americana per 3 lunghi anni, combatterà, ucciderà per non essere ucciso, vedrà i suoi commilitoni morire e soffrire prima di morire. Risentirà il peso della parola ‘guerra’. Sarà presente in più battaglie e più luoghi, mostrerà coraggio ed eroismo tanto che gli venne conferita la ‘Stella d'Argento al valore in azione’, la Silver Star, tuttora la terza più alta decorazione al valore militare negli Stati Uniti, conferita per atti di eroismo in azione contro il nemico. Solo che questa volta il nemico erano i soldati tedeschi.
Documenti provano che nel gennaio del 1944 sul Monte Porchio, nella battaglia di Cassino, Richard Stern ora promosso sergente, parlando in tedesco ad un gruppo di nazisti, bloccati in un avamposto, li fece arrendere salvando la vita a loro e a molti soldati alleati che avrebbero dovuto prenderli ed eliminarli.
Anche questa guerra finì. Richard questa volta risultava tra i vincitori e la sua Germania, la patria precedente, distrutta e trasformata in un ammasso di rovine.
Tornerà a casa e si terrà stretta la Silver Star, passata poi ai familiari quale eredità del suo tempo.
E le due medaglie tedesche? Che fine fecero la ‘Croce di Ferro’ e la ‘Croce Anseatica’, unico bagaglio quando fu costretto a fuggire dalla Germania?
Nessuno ne seppe più nulla con esattezza, tanto meno i familiari. Ma testimoni amano raccontare che subito dopo Pearl Harbor, quando iniziò la forte campagna di arruolamento, partirono anche raccolte libere di metalli, da fondere e poi trasformare in proiettili da utilizzare in guerra, nella lotta contro il nemico. Subito Richard non poté essere arruolato, ma trovò giusto consegnare le due medaglie affinché diventassero munizioni per sconfiggere il nazismo.
Le sue Croci di Ferro e Anseatica, ricevute nella guerra dalla sua Germania, ora diventavano arma di morte contro la nuova Germania. Totalmente diversa dalla prima, nella quale non più si riconosceva e da cui era fuggito.
Ma con una certezza: era stata la sua vecchia patria a tradirlo, non viceversa.
Una scelta altamente simbolica, forte, inequivocabile: trasformò il ricordo del suo eroismo in un’arma contro la tirannia nazista. Un suo modo di dire che “la patria di un uomo non è il luogo dov'è nato, ma quello dove cessano i suoi tentativi di fuggire”, che la patria non è il luogo dove tu sei venuto al mondo, ma dove tu trovi i valori su cui sei cresciuto e che consideri il tuo vangelo, la tua bussola per vivere in pace con la tua coscienza.
E quando la libertà è messa in croce, devi lottare affinché venga recuperata. Al di là delle divise, al di là dei confini, al di là delle frontiere, oltre la parola ‘patria’ quando è intesa come nazionalismo. Che è l’opposto della parola patriottismo, perché, perché “il patriottismo è amore per la propria nazione, non odio per gli altri.“
Richard è morto 22 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, era nato 16 anni prima della precedente. Ha compreso il senso della parola 'guerra' e più ancora ha scelto cosa volesse dire ‘patria’.
Oggi, 80 anni dopo la fine del nazifascismo, molti non l’hanno ancora capito e confondono i termini di patriottismo con quello del nazionalismo. Il primo amore è per la propria nazione, il secondo odio per gli altri. E sappiamo bene dove quest’ultimo porta. Due guerre mondiali e cento milioni di morti ce lo ricordano ogni momento.
2 novembre 2025
* Coordinatore Commissione Storia e Memoria dell'Osservatorio
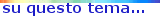 
Dossier
diritti
|
|

