 |
Quando a franare è il diritto (2)
di Silvia Tarquini
Conversazione con Alessandro Negrini su cinema, sogno, resistenza* parte 2
(torna alla prima parte)
Non solo nella tua opera incontri grandi fatti storici, politici, sociali - ne La luna sott’acqua come nei due tuoi film precedenti dedicati al conflitto tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda - ma sei un attivista in prima persona e porti avanti anche altri tipi di attività per approcciare tematiche sociali e politiche. Ricordo per esempio un tuo laboratorio sul tema del confine svoltosi a Cipro, e la tua direzione artistica della Festa del Cinema dei Diritti Umani di Cosenza. Puoi dire qualcosa su queste attività?
Fui invitato a Cipro da una Associazione di architetti, Urban Gorillas, in quella terra sospesa e ferita, dove un muro taglia ancora in due la città di Nicosia. Lì nacque Disorientando i confini, un laboratorio in cui chiedemmo ai partecipanti di andare tra i quartieri greci e turchi, di fermare le persone e domandare loro di ricordare una musica, una canzone legata a un sogno dimenticato. Poi, in quel preciso istante, quella musica veniva ritrovata e fatta risuonare nelle orecchie di chi l’aveva evocata, mentre una telecamera ne raccoglieva soltanto gli occhi - occhi che ascoltavano la memoria. Tutte quelle melodie, intrecciate, divennero la colonna sonora dei sogni dimenticati, e furono suonate proprio là, dove il filo spinato divide Nicosia greca da Nicosia turca. Da quel confine, i partecipanti lanciarono gomitoli di lana, e i fili furono raccolti dall’altra parte: i corpi iniziarono a danzare, intrecciando nemici in un unico ritmo. La sera, proiettammo Tides da due tetti, uno per ogni lato del muro, e subito dopo, gli sguardi di chi aveva ascoltato quella colonna sonira. I militari arrivarono per fermarci, ma era già troppo tardi: avevamo già, davvero, disorientato i confini.
E che cosa hai fatto in particolare in questi anni per la causa palestinese, che oggi per fortuna ha portato a impegnarsi milioni di cittadini in tutto il mondo?
Tutto ciò che faccio è intrecciato al mio cinema (o viceversa), e nasce da una convinzione personale: non ci si può dichiarare artisti se si è privi di empatia verso gli ultimi. Che senso ha citare o mettere in scena Shakespeare, Neruda, o De André se poi chiudiamo gli occhi di fronte a un genocidio trasmesso in diretta? Mi sconvolge vedere artisti che non sentono il bisogno di empatizzare pubblicamente con chi, nella realtà, incarna ciò che raccontano sul palco o sugli schermi. In Re Lear, Shakespeare scrive: “Sono tempi bui quelli in cui i folli guidano i ciechi”. Come si può portare in scena una frase così potente e, allo stesso tempo, comportarsi come quei ciechi che si lasciano guidare dai folli? Come si può raccontare la bellezza ignorando l’abominio? C’è un’immagine che mi ossessiona: quella dei musicisti del Titanic che, per ordine degli armatori, continuano a suonare mentre la nave affonda. Oggi siamo tutti sul Titanic, e troppi continuano a suonare come se nulla stesse accadendo, fingendo che l’umanità non stia affondando. L’arte che non sfida più la realtà, che non cerca di salvarsi dalla tragedia ma la accompagna con una colonna sonora dolce e inoffensiva, è un atto di resa estetica e morale. Per questo un anno e mezzo fa ho scritto una Lettera agli artisti e agli intellettuali, nella quale chiedevo a cosa servisse l’arte e a chi è indirizzata se resta muta, cieca e sorda davanti a ciò che ci accade intorno. Mi rispose per primo lo storico Angelo D’Orsi, con grande entusiasmo. Da quel dialogo nacque un’amicizia e decidemmo di fare qualcosa di concreto, non solo un appello ma un evento: GazArt, che si tenne al Teatro Villa Lazzaroni di Roma. GazArt vide partecipare artisti, musicisti, attori, cittadini comuni, tutti uniti dal desiderio di dire “non in mio nome”. Ognuno portò un testo o un intervento legato alla Palestina. Parteciparono Laura Morante, Massimo Wertmuller, David Riondino, Ascanio Celestini, Daniela Poggi, il musicista Lucio Matricardi, Vauro, Carla Carfagna, Arianna Porcelli Safonov, Claudio Silighini, Laura Frascarelli, Moni Ovadia, giornalisti come Raffaele Crocco e molti altri. Ci fu una risposta da parte di molti artisti e intellettuali, ma accolta dal silenzio quasi totale, non facemmo “notizia”. Avevamo un ufficio stampa, eppure la stampa ci ignorò: solo «Il Fatto Quotidiano» pubblicò un articolo, e «il manifesto» dedicò una vignetta di Maicol & Mirco. Oggi, per fortuna, molti artisti sembrano essersi risvegliati – forse tardi, ma meglio tardi che mai, perché ogni voce serve. Quando lo facemmo noi, fummo ignorati o accusati di antisemitismo, di essere filo-Hamas. Ma rifarei tutto, perché credo che il silenzio sia la forma più grave di complicità.
Davvero vi hanno tacciato di antisemitismo? Che in effetti è stato il refrain mediatico del tentativo di difendere Israele.
Sì, ho perso spettacoli e occasioni di lavoro: alcune date mi sono state cancellate, e ufficiosamente mi è stato riferito che la motivazione era proprio quella – che avevo “fatto un casino”, che ero portatore di elementi divisivi e antisemiti. Non voglio fare la vittima, perché non mi piace, ma è un fatto che chi è salito su quel palco ha pagato per un anno e mezzo, chi più chi meno. Tuttavia, non si può agire diversamente. Se non si prende posizione, le parole che diciamo, i film che realizziamo, le canzoni che cantiamo non valgono nulla: restano vuote, di più: ipocrite. Venendo a questi giorni, a questa risposta sorprendente e potente degli italiani – una mobilitazione come non si vedeva da tempo – è stato emozionante vedere una cittadinanza che ha finalmente capito che chi dovrebbe rappresentarla non la rappresenta davvero. Se lo Stato rappresentasse la cittadinanza avrebbe difeso i partecipanti alla Sumud Flotilla, invece si è permesso ad uno Stato occupante di commettere atti di pirateria verso propri connazionali
L’associazione “Siamo ai titoli di coda”, che raccoglie li professionisti del cinema e dell’audiovisivo italiani, si sta muovendo molto in questa direzione, e credo sia un segnale molto importante.
Sì. È altrettanto fondamentale che gli insegnanti, i docenti – che possono essere i veri custodi della memoria collettiva - aiutino a far capire che tutto questo è già accaduto. Ciò che studiamo nei libri non è un archivio polveroso, ma una finestra sul presente: La mostruosità non è un incidente del passato. La mostruosità si è sempre ripetuta e si sta ripetendo. Ai tempi del Vajont c’era un’unica intellettuale, Tina Merlin. Raccontare il Vajont oggi serve proprio a questo: a capire cosa possiamo fare nella realtà presente. Perché quel racconto non parla solo del passato, ma di ciò che ancora è. E quel racconto risuona negli occhi di chi lo guarda e resiste, di chi ancora dice “No”, nella sua vita e nel suo presente, tocca le esperienze individuali di sconfitta e di resistenza, e addita un potere che continua a tracimare oltre il diritto e la giustizia. Come l’acqua di quella diga.
Grazie Alessandro
* Intervista pubblicata su ArtDigiland.com del 9 ottobre 2025
VAI A TUTTE LE NOTIZIE SU GAZA
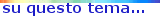 
Dossier
diritti
|
|

