 |
Potenza tecnica e responsabilità etica
di Giuseppe Franco Arguto
𝘕𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘪, 𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘢𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘚𝘤𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘝𝘦𝘨𝘦𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘛𝘦𝘭 𝘈𝘷𝘪𝘷 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘮𝘪𝘤𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘭𝘵𝘳𝘢𝘴𝘶𝘰𝘯𝘪 𝘭𝘦 𝘶𝘳𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘮𝘦𝘵𝘵𝘰𝘯𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘷𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘵𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘰 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘤𝘲𝘶𝘢. 𝘈 𝘎𝘢𝘻𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘮𝘪𝘤𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘪.
(Giorgio Agamben, filosofo, 30 ottobre 2023, "Una voce" sul sito della casa editrice Quodlibet)
Agamben si pronunciò così a poche settimane dall'inizio del genocidio a opera di Israele, in risposta all'attacco di Hamas: egli partì da un dettaglio tecnico-scientifico declinandolo in una direzione etico-politica, fino a far emergere la contraddizione più radicale.
Agamben accosta due registrazioni: il dolore delle piante che, grazie alla tecnologia, diventa udibile e quindi riconoscibile e il dolore degli esseri umani a Gaza, che non necessita di microfoni ultrasensibili perché è evidente, ma resta inascoltato, rimosso, silenziato.
Lo scarto paradossale è che il potere tecnico e scientifico si concentra sul rendere percepibile ciò che non appartiene all’ordine umano – la voce delle piante – mentre non esistono, o meglio non vengono messi, dispositivi di ascolto del dolore umano, di un popolo sotto assedio.
Come è nella classica condotta del filosofo, Agamben denuncia non tanto la ricerca scientifica in sé, quanto il dispositivo epistemico e politico che decide chi o che cosa merita di essere ascoltato. La scienza occidentale può farsi interprete persino delle “urla” vegetali, ma quando si tratta di voci umane che gridano contro la violenza e l’ingiustizia, scatta il silenziamento.
Non è un problema di capacità tecnica, ma di volontà politica e di strutture mediatiche che occultano, selezionano, censurano.
Una denuncia che già allora mette in rilievo una gerarchia aberrante: il dolore vegetale diventa un oggetto di conoscenza e di stupore, mentre quello umano – infinitamente più prossimo, devastante, visibile – non trova strumenti di registrazione, cioè di riconoscimento e trasmissione.
È l’immagine di un mondo in cui la compassione viene deviata: si ascoltano i vegetali, ma non i bambini che muoiono sotto le bombe.
La questione filosofica: ascoltare l’inudibile, è questo su cui riflette Agamben, sul limite fra ciò che ha voce e ciò che ne è privo. Qui ribalta la prospettiva: la scienza si vanta di rendere udibile ciò che non ha voce (le piante), ma proprio mentre tace sull’orrore evidente.
Chi decide che cos’è degno di ascolto? E soprattutto: quale potere sovrano stabilisce la soglia tra un grido che diventa evento mediatico e uno che resta senza eco?
Lo stabilisce il capitalismo a mezzo della tecnocrazia che in USA e in Israele soprattutto ha trovato le sue basi operative.
Il riferimento a Gaza non è casuale: evoca l’estrema zona d’eccezione, dove la vita è ridotta a mera sopravvivenza biologica, la nuda vita di cui Agamben scrive da decenni. La mancanza di microfoni significa: mancanza di testimoni, mancanza di riconoscimento, cancellazione della sofferenza umana dal registro della comunicazione globale.
È un atto d’accusa contro la scissione tra sapere e giustizia, tra potenza tecnica e responsabilità etica, che segna il nostro tempo.
VAI A TUTTE LE NOTIZIE SU GAZA
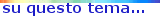 
Dossier
diritti
|
|

