 |
I bambini del carabiniere di Rodi
di
Rinaldo Battaglia *
Cugliate Fabiasco, terza settimana di settembre 2011.
Nella Chiesa parrocchiale di San Giulio si celebrano i funerali di un anziano del posto, deceduto alla veneranda età di 86 anni, lunedì 19 settembre, 13 anni fa come oggi. La Chiesa è gremita, ci sono perfino molte persone che non riescono ad entrare. Eppure, quel piccolo paese del varesotto conta all’anagrafe solo 3.000 anime.
Come oramai da prassi, sul finire della cerimonia, Filippo, uno dei figli prende la parola. L’altro, il maggiore, e la vedova non se la sentono: troppo il dolore. E tra qualche pausa e mille sofferenze, Filippo racconta chi era suo padre. I presenti restano di sasso, perché vengono a sapere ulteriori qualità di quell’uomo, troppo generoso e semplice per passare inosservato.
(...)
...a Rodi nel lontano fine 1943, dopo la disfatta italiana dell’8 settembre e dopo che le eroiche truppe dell’Ammiraglio Inigo Campioni si erano arrese ai nazisti, il giorno 11, solo per evitare che la città di Rodi (e buona parte dell’isola) fosse bombardata dalla Luftwaffe e, come ordinato da Berlino, dal cielo rasa al suolo.
A quel tempo di fame e di guerra, Enrico Ricciardi aveva solamente 18 anni. Un ragazzo, un giovanotto. Nulla di più. Classe 1925, classe di ferro, classe nata nel primo fascismo del Duce, cresciuta nella scuola delle marce obbligatorie e del sabato fascista di Starace, allevata per la gloria della Patria, lì peraltro – a Rodi - divenuta Italia da poco, solo dal 1912. Il capitano Carlo Pellegrino era, invece, già un affermato ufficiale di oramai 50 anni, superstite della tragedia della Grande Guerra e a quel tempo Comandante dei Carabinieri dell’intera isola.
Uomo di spicco, riferimento di tutti proprio ora che tutti, a Rodi, erano preda della criminalità delle truppe del Fuhrer, i nuovi padroni. Anche a Rodi si era italiani e quindi, con l’armistizio di Badoglio, per i nazisti si era colpevoli di tradimento e, come non bastasse, lontani anni luce dalla madre patria. Soli ed abbandonati al proprio destino. Nulla di meno. Ognuno così cercava di salvarsi la vita come poteva e, per primo, riempire lo stomaco di giorno in giorno sempre più vuoto. Anche il giovane Enrico.
Gli Alleati dopo l’8 settembre, infatti, avevano messo in piedi su Rodi e su tutta la Grecia un feroce blocco navale, per frenare la forza dei nazisti. La gente – dirà un giorno Enrico al figlio Filippo – “moriva letteralmente di fame e i morti non si contavano, spesso si nascondevano per non perdere la scarsa razione quotidiana assegnata a ciascun nucleo familiare”. Filippo capiva bene il morso di quella fame: aveva ben presenti alcune foto vecchie del nonno Edmondo – “un apprezzato e stimato funzionario di banca” - e del padre, coi volti “irriconoscibili, deperiti e con lo sguardo spento nei loro occhi”.
Ma non regnava solo la fame a Rodi: il terrore non era di meno.
A quel tempo a Rodi i nazisti avevano due prede preferite: gli ebrei e i giovani del posto. Enrico era nella seconda categoria di cacciagione. Tutti i giovani fino alla classe ’23 Mussolini li aveva già chiamati alla guerra. Chi non era ancora morto o già deportato come IMI nel lager, nessuno sapeva in quale angolo di mondo fosse finito. Tra questi anche Antonio, classe 1919, suo fratello maggiore, ufficiale del Regio Esercito e che in famiglia sapranno che era vivo, solo quando lo vedranno tornare a fine guerra, salvatosi ‘più volte anche in modo rocambolesco’. I prossimi nella lista, a Rodi, erano così quelli nati nel ’24 e nel ’25: ma ora erano i tedeschi a prenderseli, per spedirli come schiavi in Germania a lavorare e morire di fatica e non solo di fame.
Il terrore regnava sovrano, ma non tutti accettarono supini e subirono senza reagire.
Ogni tanto nel pianeta ci sono segni di vita.
Molti anni fa, Roberto Bazlen, un grande intellettuale amico di Eugenio Montale e Umberto Saba, che aveva vissuto da ebreo nella sua Trieste quegli anni, scrisse che ‘un tempo si nasceva vivi e a poco a poco si moriva. Ora si nasce morti. Solo alcuni riescono a diventare a poco a poco vivi’.
A Rodi a dimostrare di essere ancora vivi, per primi, ci furono i ’Fratelli delle Scuole Cristiane’ – chiamati in loco ‘i Lassaliani’ – e soprattutto il loro priore, fratel Angelino Guinot. Conoscevano molti di questi ‘candidati al lavoro in Germania’. Tantissimi, anni prima, erano andati – come Enrico – a scuola da loro, ricevendo ‘un’educazione improntata all’ecumenismo’, alla convivenza pacifica e rispetto reciproco tra le varie comunità religiose dell’isola, dove da numerosi secoli convivevano, in piena solidarietà e amore fraterno, cristiani cattolici, greci ortodossi, musulmani convinti e una millenaria comunità ebraica.
Prima della guerra del ’40 e delle leggi razziali del Duce del ’38 – sono parole di Filippo, frutto dei racconti del padre ma anche da moltissime testimonianze giuntegli – “Ogni comunità era invitata alle feste di ciascun gruppo religioso. La famiglia di mio padre era regolarmente alle funzioni religiose e alle feste familiari in occasione delle più importanti ricorrenze ebraiche, ortodosse e musulmane e viceversa, con una naturalezza oggi difficilmente comprensibile e quasi accostabile a un’utopia. A scuola, senza distinzioni, mio padre ha avuto compagni di classe ebrei, ortodossi, e musulmani. I programmi di istruzione prevedevano il rispetto per ciascuna comunità! In questo ambiente fertile, incoraggiato dalla solida educazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, mio padre passò (parole sue) i “più begli anni della mia vita”.
Fratel Angelino Guiot e i suoi confratelli, decisero di muoversi subito e in silenzio, per non attirare le ire del nuovo ‘padrone’, ma sempre in modo determinato e chiaro. Prima che succedesse l’irreparabile, ancora prima che la gente di Rodi se ne rendesse conto.
Presero carta e penna, trovarono dai loro vecchi elenchi il nome di quei ragazzi, ora in età di leva e a rischio deportazione e si misero in contatto. Tra questi, anche Enrico. Fratel Angelino aveva ideato una soluzione. In quel momento i nazisti avevano bisogno - per il controllo dell’isola - anche dei nostri Carabinieri, in quanto dotati di funzioni di Polizia Militare. In altre parole, essendo già arruolati ed utilizzati con compiti di Ordine Pubblico, non avrebbero potuto di conseguenza deportarli. Li servivano per altri scopi, altrettanto basilari per loro. Avrebbero cercato, e preso, altrove schiavi per le loro fabriken. La salvezza di quei giovani era l’arruolamento immediato nei Carabinieri di Rodi.
Ed in questo, la stima reciproca tra Fratel Angelino ed il capitano Carlo Pellegrino - che aveva anche funzioni di Questore - fu essenziale.
In poche settimane Enrico Ricciardi, sebbene di soli 18 anni, non ancora 19, indossò ‘da volontario’ la divisa e acquisì una speranza in più per tutti. Famiglia compresa. A suo figlio Filippo, già anni prima e in più occasioni, aveva raccontato come varie volte, di notte, suo padre Edmondo arrivasse vicino alle inferriate della zona militare e di ‘come lui gli passasse la sua razione quotidiana da portare a casa’. Rinunciando così alla propria cena.
E da Carabiniere cominciò a capire, e peggio vedere, anche la tragedia dell’altra categoria di cacciagione preferita dei nazisti: la comunità ebraica, molto fiorente e numerosa a Rodi. Già sapevano dei campi in Germania ove altri ebrei venivano sterminati col gas solo perché ebrei, di retate, di rastrellamenti, di massacri nei ghetti, di bambini uccisi o sepolti vivi.
Enrico non era ebreo: ma poteva far finta di nulla? Era appena finito, come servizio, nella Questura della capitale, nella sua città, all’ufficio dei passaporti, chiuso dentro una stanza tra le carte e la polvere, poteva anche fregarsene. Perche no?
‘Un tempo si nasceva vivi e a poco a poco si moriva. Ora si nasce morti. Solo alcuni riescono a diventare a poco a poco vivi’ scriveva Roberto Bazlen.
Ma non solo Fratel Angelino e i suoi ‘’Fratelli delle Scuole Cristiane’ decisero di esser vivi. Anche il giovane Enrico, sul finire del ’43, scelse così, a modo suo. Se la divisa dei Carabinieri gli aveva salvato la vita, ora con quella divisa doveva salvare altre vite. I ‘Fratelli delle Scuole Cristiane’ gli avevano insegnato una soluzione, ora Enrico ne trovava delle altre.
In ufficio aveva a disposizione un buon numero di matrici della carta di identità italiana, aveva la possibilità di entrare in possesso, leggere e verificare la lista delle persone censite ed etichettate – dopo le leggi razziali del Duce - come di ‘razza ebraica’. E così senza che niente e nessuno gli chiedesse nulla – neanche gli ebrei direttamente interessati e comunque sempre a loro totale insaputa – eccolo che iniziò, quasi per istinto, quasi per reazione chimica, ‘a scrivere nomi e cognomi e date di nascita, modificando quelli originali di suoi cari amici ebrei e dei loro familiari’. Li conosceva, era cresciuto con loro, giocato assieme, uscito già con qualche ragazza tra quelle segnalate ‘come di razza inferiore’. Che colpa avevano?
A gennaio ’44 le cose anche a Rodi presero una brutta piega per gli ebrei ed in maniera molto veloce. Sebbene al comando dell’isola vi fosse ancora il ‘General derPanzertruppe’ della Wehrmacht, Ulrich Kleemann - un amico personale di Hitler - molto meno fanatico di altri gerarchi ma comunque sempre il massacratore della guarnigione italiana dall’8 all’11 settembre ’43, la caccia si rafforzò e le prede cercarono ogni angolo di salvezza. Il nome del giovane carabiniere dell’ufficio passaporti della Questura cominciò così a girare nella comunità ebraica, trovando terreno fertile. E dalla ‘correzione’ dei dati anagrafici alla ‘produzione’ di documenti falsificati o fasulli fu breve.
Tutto molto in sordina, tutto molto in silenzio. Ma non poteva durare.
Una mattina d’inizio inverno fu chiamato a rapporto nell’ufficio dal suo comandante, il Capitano - nonché Questore - Carlo Pellegrino. Era la prima volta che succedeva. Spaventato, Enrico si presentò e dopo un formale saluto, il capitano lo guardò bene negli occhi, lo squadrò e gli disse solo due parole: “Carabiniere Ricciardi, so cosa sta facendo, io non so nulla ma Dio vede!”.
Altre parole non servirono perché tra uomini, quando si è uomini, le parole contano meno dei fatti.
Ritornato nel suo ufficio, Enrico riprese ancora con più vigore la sua attività di falsario. Ed in breve, quella divenne una ‘catena di montaggio’, perché anche altri stavano dando una mano, ognuno all’insaputa dell’altro, in silenzio, senza che nessuno chiedesse nulla. Avevano bisogno solo di sapere da che parte stesse chi era in alto – il capitano/questore Pellegrino – perché questi poteva o meno frenare, rallentare, sviare le azioni del gen. Ulrich Kleemann, di cui godeva ampia fiducia.
Enrico Ricciardi falsificava documenti agli ebrei che si rivolgevano ai Carabinieri – altri ‘complici’ - o direttamente anche al Cap. Pellegrino, Fratel Angelino Guiot e i suoi delle ‘Scuole Cristiane’ davano riparo in attesa della loro fuga, come facevano anche famiglie contadine del luogo. E di notte piccole barche di pescatori trasportavano i fuggitivi verso le coste della terraferma turca o delle sue isole. Durante la guerra, la Turchia era rimasta neutrale, malgrado che Churchill da una parte e Hitler dall’altra cercassero giorno su giorno di tirarla per la giacca e coinvolgerla nel conflitto a proprio favore. Era rimasta neutrale e divenuta una piccola Svizzera per gli ebrei dell’intera Grecia, in particolare quelli di Rodi e del vicino Dodecaneso.
Ogni notte partivano più barche, ciascuna con 7/8 persone in fuga, anche meno, ‘con un fagotto di poche cose e soprattutto con la carta di identità rifatta’. Poche persone, non molte per non destare sospetto e al mattino i pescatori ritornavano carichi di pesce fresco ma senza di loro. Nessuno, né Enrico, né altri riuscì mai a quantificare il numero dei ‘salvati’, perché quei viaggi erano continui, costanti, da più porticcioli vicino alla capitale, in autonomia. Di certo un centinaio, forse molti di più. Non si tenevano dati, tracce o liste, talvolta Enrico non riusciva nemmeno a memorizzare quei volti, carichi di paura ma anche grati per la speranza a loro offerta in cambio di nulla.
Fu un lavoro di squadra iniziato e partito, per istinto o forse per il cuore, dal giovane carabiniere dell’ufficio passaporti della Questura di Rodi. Un lavoro tacito, segreto, senza tante parole. Ognuno sapeva cosa fare e lo faceva. Sapendo quale fosse il rischio ed il prezzo eventualmente da pagare. I nazisti erano pur sempre ‘nazisti’.
Le cose peggiorarono fortemente a settembre del ’44 quando al posto del gen. Ulrich Kleemann arrivò il gen. Otto Wagener, un sanguinario, antisemita fanatico e criminale già affermato. E vi sono due date che sintetizzano quella atroce realtà: il 23 luglio e il 3 settembre 1944. Wagener ordinò due retate sugli ebrei dell’intera isola di Rodi. Nella prima tra i catturati vi fu anche la famiglia dell’allora ragazzo Sami Modiano. Sarà l’unico a tornare da Auschwitz-Birkenau e ancora oggi a testimoniare.
Nella seconda i nazisti arrivarono anche alle Scuole Cristiane di Fratel Angelino Guiot e catturarono tutti i bambini ebrei lì presenti, in parte nascosti, in parte non ancora.
Fratel Angelino arrivò persino, parlando un fluente tedesco, ad offrirsi in cambio di quei ragazzi terrorizzati. Personalmente anche al generale Wagener, ma senza esito. Anzi lo stesso generale nazista gli puntò più volte la pistola contro.
In pochi giorni nell’isola vennero deportati oltre 1.800 ebrei, in particolare sterminando del tutto la comunità e la storia dei Safarditi di Rodi. Erano arrivati in fuga dalla Spagna a seguito del Decreto dell'Alhambra già nel XVI secolo, e avevano qui poi creato il quartiere ebraico, chiamato La Djuderia, dove si toccarono col tempo anche 5.000 residenti. Dopo Wagener La Djuderia non esisterà più. Era sopravvissuta agli arabi, ai greci, agli ottomani, ai turchi di Kemal Atatürk, ma non ai demoni di Hitler. Si salveranno solo alcune decine di uomini scampati dai lager della Shoah e qualche altra decina fuggita prima della catastrofe, probabilmente grazie ai servigi occulti della Questura di Rodi o di altri, ma sull’esempio ed esperienza sempre dei “connotati” lì rifatti.
L’attività della Questura di Rodi proseguì sia dopo il 23 luglio che il 3 settembre: i rischi aumentavano ma non ci si poteva fermare. Altre vite da salvare e altri documenti da falsificare lo imponevano. Anche se non si poteva più contare sulla protezione del capitano Pellegrino, da allora costretto a scappare “braccato dai tedeschi perché soprattutto in lui vedevano colui che aveva aiutato gli Ebrei e i soldati italiani”.
Ma ugualmente si proseguì fino a che serviva, fino alla tarda primavera del ’45: dopo per i nazisti l’oroscopo cambiò. Già dall’8 maggio si arresero agli Alleati e se ne andarono di corsa.
Enrico ritornò così ad un servizio più ‘abituale’ per un carabiniere, ma dopo il 10 febbraio 1947 - quando nella Conferenza di Pace di Parigi anche Rodi e tutto il Dodecaneso furono assegnati alla Grecia, quale rimborso dei danni della guerra fascista - preferì venire nella sua Italia. La fame e le macerie, fisiche e morali, erano uguali sia da una parte che dall’altra ma, se fosse bisognato ricostruire, tanto sarebbe valso farlo qui.
Arrivò così nel milanese e a seguire dalle parti di Cugliate Fabiasco.
(...)
Parlava e raccontava tutto ma mai, mai a nessuno del periodo ‘ottobre ‘43 – maggio 1945’. Era il suo segreto.
Una sera, pochi mesi prima di morire, forse convinto che stesse arrivando la sua ora, al figlio Filippo confessò quel ‘vuoto’. Era arrivato il momento giusto e non voleva andarsene senza che qualcuno di caro non lo sapesse. Voleva passare ad altri il suo testimone. Aveva le lacrime agli occhi e piangeva come un bambino. E raccontò, senza fermarsi, di quel giovane carabiniere, degli ebrei salvati, dei Fratelli Lassaliani di Fratel Angelino, dell’amico capitano Pellegrino, che aveva sempre saputo quel che faceva e sempre – talvolta a sua insaputa – lo aveva protetto dai nazisti, fino ad esser costretto a nascondersi. Per salvare gli altri ‘complici’.
Ma tutte quel bene fatto non lo soddisfaceva. Non era stato sufficiente. Piangeva non per le vite – centinaia e centinaia, forse molte di più – che aveva contribuito a salvare, ma tutte quelle dove non era riuscito a farlo. A tutti quei nomi di ebrei a cui non aveva modificato ‘la razza’ nell’albo anagrafico per tempo, a tutti coloro che non era riuscito a consegnare un documento falso, a tutti coloro che non erano stati appositamente informati e non avevano potuto beneficiare dei ‘servigi’ occulti della Questura.
Non pensava ai bambini salvati, ma ai bambini perduti. Fu lì che Filippo capì l’amore che aveva quando insegnava musica e canto agli scolaretti del paese e perché amava salutarli in greco. In loro vedeva i figli di chi aveva salvato e quel ‘ Jassaspediamu!‘ (Salute figli miei!) ora aveva un suono diverso.
Filippo promise al padre, come richiestogli, che lo avrebbe accontentato: fino al giorno della sua morte non avrebbe reso pubblico quanto saputo e dopo, solo dopo, avrebbe portato avanti il testimone del padre. Lui non era riuscito a farlo totalmente: il dolore per chi non aveva salvato non gli aveva permesso di parlare di chi era invece sopravvissuto. E forse senza volerlo, era il medesimo pensiero che aveva avuto, a suo tempo, il capitano Pellegrino col figlio.
Enrico Ricciardi non voleva medaglie per sé, ma solo urlare al mondo che anche quando, come ora, ‘si nasce morti’ – perché a troppi questo conviene – bisogna assolutamente ‘diventare a poco a poco vivi’. Costi quel che costi. Anni prima un altro eroe di quegli anni (Gino Bartali), parlando del suo analogo silenzio aveva semplicemente detto che “Il bene si fa ma non si dice. E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca”.
Filippo Ricciardi ha preso in mano il testimone e ha iniziato a parlare sul valore di quanto imparato dal padre. Alcuni giornali, anche se soprattutto locali, hanno più volte scritto le sue iniziative. Ha attivato piccole conferenze (come a Locarno il 6 aprile 2013, da cui ho ripreso alcune sue parole), incontrato scolaresche, ha creato memoria.
Il nome di Enrico Ricciardi è stato di recente inserito, a pieno titolo, nel ‘Giardino dei Giusti’ grazie all’Ass.ne Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), una ONLUS con sede a Milano, che vanta molte collaborazioni internazionali in coerenza con lo Yad Vashem di Gerulasemme, dove come ‘Giusti fra le Nazioni’ si onorano tutti i non-ebrei che durante la Shoah aiutarono gli ebrei a salvarsi. Il massimo riconoscimento per loro. Almeno sulla terra.
Il 1° maggio 2022 l'amministrazione comunale della sua Cugliate Fabiasco – inoltre - gli ha intitolato la Sala Civica del paese, con tanto di cerimonia ed onori.
La memoria tra mille difficoltà, quindi, sta proseguendo faticosamente il suo percorso, grazie a Filippo. Perché nella vita servono esempi ed esperienze positive per aprire la strada e gli occhi a chi forse vorrebbe ma si sente solo, isolato, mortificato. O meglio. Riprendendo Roberto Bazlen. Si crede ‘nato morto’ ma sta cercando di ‘diventare a poco a poco vivo’.
(...)
Siamo oggi più vicini al carabiniere Enrico Ricciardi e al capitano Carlo Pellegrino o ai generali del male quali Ulrich Kleemann e peggio Otto Wagener, peraltro in quel momento soci ed alleati dei nostri fascisti ora in Italia esaltati?
Hannah Arendt – ben titolata a farlo e meritevole del massimo ascolto – diceva che
“Da quando il passato non proietta più la sua luce sul futuro, la mente dell'uomo è costretta a vagare nelle tenebre.”
Ultimamente mi sembra che, in Italia, troppo spesso si confonda la luce con le tenebre, perché abbiamo perso di brutto le lezioni del passato. Come quella di Enrico Ricciardi ed è doloroso pensarlo. Com’è doloroso ed avvilente ritenere che quel passaggio del testimone stia oramai del tutto fallendo.ù
19 settembre 2025 – 14 anni dopo -
Liberamente tratto dal mio ‘Il tempo che torna indietro – Terza Parte” - Amazon – 2025
* Coordinatore Commissione Storia e Memoria dell'Osservatorio
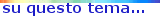 
Dossier
diritti
|
|

