 |
Una donna senza colpe
di Roberto Neri
“Claretta Petacci era una donna senza colpe. E quello che ha subito, anche da morta, è stato nefando” scriveva Pansa due decenni fa alludendo al “colonnello Valerio” che la colpì, e che da quel momento venne marchiato come “uccisore di donne inermi” dagli avversari e non solo. Quale fu poi la vita del giustiziere del Duce e della sua donna?
Nato il 28 giugno 1909 ad Alessandria, il “colonnello Valerio”, al secolo Walter Audisio, è un venticinquenne contabile della “Borsalino”, storica fabbrica di cappelli della sua città, quando viene catturato perché attivo nell’opposizione clandestina al regime di Mussolini.
Rivede la moglie Ernestina dopo cinque anni trascorsi in galera e al confino sull’isola di Ponza, dove si ammala gravemente, motivo per il quale può tornare da lei, anch’essa malata e senza mezzi, però soltanto dopo aver rinnegato l’antifascismo. La pleurite gli evita la guerra. Torna a fare il ragioniere.
Quando cade il fascismo Audisio riappare tra le fila della Resistenza; diventa uno dei comandanti partigiani più apprezzati. E’ pure uno dei principali ricercati dal nuovo regime di Salò; agisce fra Piemonte e Lombardia, e verso la fine della guerra raggiunge il grado più alto della polizia militare di tutta la Resistenza.
Al “colonnello Valerio” (il suo vero nome resterà ignoto ai più per anni) il 27 aprile 1945 viene affidata la missione di prendere in consegna il Duce, appena fermato a Dongo dai partigiani mentre stava fuggendo, e di portarlo a Milano per processarlo; l’incarico è firmato dal Comitato nazionale per la Liberazione dell’Alta Italia, il CLNAI.
Benché munito di lasciapassare, Walter fatica a raggiungere l’abitazione dove sono prigionieri Mussolini e la Petacci, separati dagli altri italiani arrestati ieri. Sono ore difficili; c’è la concreta minaccia che per togliere il Duce dalle mani del CLNAI piombino qui milizie fasciste o agenti degli Alleati.
La condanna capitale, implicita ma chiarissima nel recente proclama “arrendersi o morire” ai fascisti, viene così decisa dal CLNAI; la sua immediata esecuzione tocca ad Audisio che, dopo un breve processo, fa mettere Mussolini al muro di una villa a Giulino di Mezzegra (Como) e spara; sulla traiettoria delle raffiche di mitra si pone di colpo la Petacci, che non era condannata, restando uccisa.
Poi Walter torna a Milano coi cadaveri, pubblica un sommario rapporto e sparisce. D’accordo col Partito comunista del quale è un aderente, per proteggere la sua incolumità non ne viene reso noto il vero nome. Sono infatti attive, nei mesi dopo la Liberazione, cellule clandestine di “vinti”, armate e vendicative.
Parte pure una campagna degli ex del regime che, rancorosi, accusano la Resistenza di crimini, tra i quali l’uccisione della Petacci; la famiglia della donna, una volta appreso chi era “il colonnello Valerio”, lo trascina a processo chiedendone la condanna per omicidio volontario pluriaggravato, appropriazione indebita e vilipendio di cadavere.
Viene perfino riesumata la salma della Petacci per una seconda autopsia che rafforzi le accuse contro Audisio, che intanto è divenuto suo malgrado un personaggio pubblico. Basco in testa, baffetti alla Clark Gable, il freddo e autorevole ragioniere si ritrova arruolato di nuovo, stavolta però dalla politica, per la sua eloquenza e per ciò che incarna.
Dal 1948 l’ex colonnello Valerio per tre volte viene eletto deputato nelle prime legislature della Repubblica italiana, poi nel 1962 diventa senatore, sempre per il Partito comunista. Sono anni nei quali esce una ridda di memorie e interviste sulla fine di Mussolini e della Petacci in particolare, che sarebbe morta perché faceva da scudo al suo uomo.
Walter non entra in queste polemiche.
Dopo un breve giro di comizi organizzati apposta nel 1947 perché si conoscano quei fatti e la vera identità del suo protagonista, Audisio passa ad occuparsi di compiti legati alla sua carica, e del processo Petacci, per il quale la Camera a maggioranza gli revocherà la sua immunità di parlamentare.
Solo vent’anni dopo Audisio viene assolto perché, avendo agito durante la guerra contro i nazifascisti, mentre erano ancora attivi gli occupanti stranieri, non lo si può punire. Nel frattempo, oltre che deputato Walter è stato allo stesso tempo anche in consiglio comunale a Casale, nel suo Monferrato dove aveva pure combattuto a lungo.
Proprio nel corso di una seduta del Consiglio comunale di quella città, poiché diffamato come un “uccisore di donne inermi” dal consigliere di minoranza Venesio, perde le staffe e gli risponde per le rime. E’ forse l’unica volta che Audisio ha una reazione non proprio razionale in vita sua.
E’ il 1968 quando chiude con la politica e torna a fare il contabile, all’Eni stavolta. Si trasferisce nella capitale. In una delle rare interviste appare provato dall’essere un mito della Resistenza per molti, o un freddo ed implacabile esecutore di ordini, se non un boia, per altri. Ama pescare, e leggere; Stendhal, Moravia e Shaw.
Si muove lento perché malfermo di salute. Muore l’11 ottobre 1973, colpito a casa da un infarto, il terzo, fatale, di una serie iniziata parecchio tempo primo; ha sessantaquattro anni. La fedele Ernestina, con la quale non ha avuto figli, alcuni mesi più tardi fa pubblicare l’autobiografia di Walter.
“In nome del popolo italiano” è il titolo di questo libro postumo in cui Audisio, chiamato in causa negli anni da scoop di bassa lega, rivelazioni di presunti partigiani e pubbliche calunnie, rivendica la giustezza di quanto fatto per la Resistenza, incluso aver sparato alla Petacci senza volerlo.
Di quella fucilazione si parlerà ancora, in modo talvolta scomposto fino agli anni Novanta, ma la versione dell’ex colonnello Valerio, narrata sopra, confermata dal CLNAI e dalle memorie dei due altri partigiani presenti, resta granitica. Audisio, per un paradosso della Storia, sarà sepolto a pochi metri dalla Petacci, al cimitero romano del Verano.
Buon compleanno, Walter.
(la frase iniziale di G. Pansa appare in “La grande bugia. Le sinistre italiane e il sangue dei vinti” 2006, Milano, Sperling & Kupfer editori. Altra fonte è l’articolo di Idro Grignolio dal volume “Un secolo di Monferrato” pubblicato nel 1999 dal bisettimanale d’informazione “il Monferrato” p. 39)
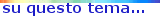 
Dossier
diritti
|
|

