 |
Come si può restare indifferenti e brigare nel quotidiano?
di
Nevio Gambula
Si sta arrivando al culmine dell’orrore, senza però indignarsi quanto basta per fermarlo. Perché?
Io racconto, commento, esprimo il mio disappunto; ma non sono in grado di smuovere nulla, circondato come sono da persone che si tengono distanti da ogni azione e, persino, da ogni tipo di protesta pubblica. E davanti allo spiegamento di tanta indifferenza, il disgusto per il genocidio diviene una sensazione privata, quasi una ridicola ossessione. Dove l’indifferenza è la normalità, condannare il genocidio è un’anomalia, quasi una malattia psichiatrica.
Talvolta, per sincera curiosità, mi chiedo qual è il limite di sopportazione dell’orrore; ogni risposta mi spaventa. Ciò che sino ad oggi non è riuscito a smuovere le coscienze, come potrà farlo domani? È come se avessimo scientemente abolito la conoscenza e la critica; e dunque rinunciato all’impegno della coscienza.
Io, figlio delle contraddizioni della democrazia, non conosco giorno in cui non mi ripeta che in ogni palestinese ucciso, in ogni massacro o distruzione c’è un pizzico di mia responsabilità. Una responsabilità “etica”, che ha fondamento nell’essere io stesso un rappresentante della specie umana. Ho sempre pensato – e lo penso tutt’ora – che per essere parte di una comunità democratica bisogna vegliare sui diritti: sognare una giustizia che riguardi ognuno e tutti.
Ma capisco chi si fa scivolare addosso gli orrori del mondo; troppi e troppo volgari, meglio dedicarsi ad altro di essenziale. Tutti gli orrori sono compromettenti, si vive meglio rinunciando a comprenderli e denunciarli; meglio adattarsi alla totale assenza di senso umanitario.
Per altro, stiamo parlando di un popolo che viene presentato come prossimo al medioevo, barbaro, incivile; insomma, non degno della nostra attenzione. E così, il peggiore dei mali – questo è il genocidio, il peggiore in assoluto – non sollecita alcuna reazione; la maggioranza dei miei simili – lo verifico tutti i giorni, anche qui, su questo social – non lo trova tanto importante da liberare lo sdegno o la riprovazione.
È come se si muovessero non tanto «al di fuori del bene e del male», visto che in altre situazioni assumono una posa morale, bensì in un luogo in cui i comportamenti si pesano sulla superbia di essere estranei a certi accadimenti; emancipati, per così dire, dal dovere di biasimare un genocidio che, in fondo, riguarda l’altro da noi, il radicalmente altro.
Troviamo esagerata la reazione della gentile signora che investe un ladro, e lo diciamo, mentre ci lascia indifferenti la reazione spropositata di Israele. Tutto ciò che appartiene all’etica è una sfumatura; più ci si allontana da noi stessi, più regredisce la nostra attenzione all’altro. Oggi siamo in grado di mobilitarci se il nostro vicino di casa sporca il cortile, ma non quando un campo profughi viene investito dalle bombe. Viviamo nell’epoca della degradazione dell’etica a schermo con cui ci nascondiamo alla “comune umanità”.
Eppure, è in gioco la nostra esistenza in quanto esseri umani. Esistere significa essere nella realtà. Ma che tipo di esistenza è quella che non partecipa della sorte degli altri?
Sì, il tema è antico, ed è quello del rapporto tra la partecipazione alle sorti del mondo e quello dell’estraneità a esso, ossia tra l’azione di trasformazione, sempre razionale e consapevole, e l’indifferenza quasi animalesca, priva di interesse per i sistemi di potere che regolano le nostre vite.
Il genocidio è l’orrore più grande che possa adombrare la realtà. Come si può “brigare nel quotidiano” quando è in corso un genocidio?
VAI A TUTTE LE NOTIZIE SU GAZA
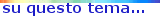 
Dossier
diritti
|
|

