 |
Cerea, 13 settembre 1943
di
Rinaldo Battaglia *
Mazzola non era nato fascista, si era solo vestito per poter giocare a calcio, avere un lavoro, poter vivere insomma. Come suo padre. Troppo giovane per fare la Grande Guerra e ora troppo vecchio per andare al fronte nella Nuova Guerra. Ma anche non così stupido o ubriaco da non capire, quella sera del 10 giugno, che sarebbe stata un’altra tragedia. E come tutte le tragedie, ogni rappresentazione è sempre peggiore della precedente perché ha quel parametro, quel riferimento con cui confrontarsi.
Il padre era un uomo a posto. Grande lavoratore, operaio della meccanica alle Officine Pellizzari durante il giorno, contadino alla sera e alla domenica, dal dopo-messa fino a sera nei campi di casa. Come non bastasse per mantenere la famiglia, faceva anche lavori come muratore nelle case vicine, soprattutto dopo che aveva sistemato la sua, attirando le attenzioni benevoli della contrada. Prima della guerra veniva spesso chiamato a fare piccoli lavori: un’altra camera, sistemare la ‘tezza’, aggiustare il tetto dopo la grandinata. E ogni tanto si portava dietro come garzone proprio il figlio primogenito. Masticare un lavoro in più poteva sempre servire nella vita e specie in quegli anni di vacche magre.
Per Mazzola invece era stato tutto più facile. Era fascista ‘per fuori’, ma fino all’anno prima non sapeva se lo era anche ‘per dentro’. Tutto era fascista. La scuola, la ginnastica, il campo di calcio, la squadretta di calcio, il lavoro, le pause del lavoro, le adunate. Tutto era fascista e gli stava molto stretto, ma lo sopportava ancora abbastanza bene. Forse proprio per questo, fu più facile per lui comprendere prima e meglio degli altri sui coetanei, cosa stesse vivendo.
Ma la svolta, quando capì di non essere fascista ‘dentro’ , avvenne solo a metà settembre dell’anno precedente, il giorno 13 settembre 1943 precisamente. Quel giorno, non lo si è mai bene afferrato - ma forse era solo una balla per non andare più a fondo ed arrivare alla triste realtà, quella che tutti già sapevano ma nessuno voleva ammettere o accettare - quel giorno era stato ammazzato il cugino Ottenio, quello di Cerea.
Ottenio (Ottenio Ongaro) aveva un nome difficile quanto era difficile saltarlo a calcio quando lo marcava nei campi di casa sua. Mazzola andava spesso a trovarlo, d’estate e di domenica soprattutto. Una corsa in bici con altri cugini per cinquanta km a tutta velocità. Ottenio era più giovane di un anno, ma era forte, piccolo se vuoi ma molto simpatico. Inspiegabile come sia stato ucciso peggio di un fagiano in un giorno di caccia. Si era solo fermato in bici a vedere un treno che era bloccato in mezzo alla campagna, vicino al passaggio al livello, poco lontano dalla casa di un altro suo zio, zio Erminio, custode del cimitero di Cerea a quel tempo. Ma dentro il treno c’era gente che gridava e urlava forte. Si era avvicinato, senza capire. Chi era dentro gridava ed urlava ancora più forte. Una parola soprattutto: ‘acqua’. Acqua. ACQUA. Sempre più forte e sempre senza pause. Lacerante.
E ora che Mazzola era anche lui dentro un vagone per bestiame, capiva di certo cosa volesse dire quella parola. Daresti tutto per un sorso di acqua, quando sei in quelle situazioni e in quei momenti.
Quando Ottenio stava arrivando verso il treno, vide i tedeschi di guardia armati fino ai denti e subito d’istinto si fermò. Senza capire. Erano Alleati degli italiani. Appena il treno partì lentamente, i disperati dal treno lo videro e le urla divennero ancora più forti. In un attimo dalle feritorie dei vagoni gli lanciarono fogli bianchi, lettere o qualcosa del genere. Dei bigliettini, meglio. Ottenio ancora quasi d’istinto cercò di prendere uno, il più vicino, per leggere e meglio capire. Fino ad allora quei vagoni sporchi, un po’ rotti, che passavano sulla rotaia verso Verona, trasportavano solo vacche o cavalli. Mai uomini. La tradotta per gli uomini passava sempre ogni giorno, ma non certo come quella, non certo in quelle condizioni. Non riuscì a leggere bene le parole scritte. Un tedesco da sopra il tetto del vagone gli sparò secco. Un colpo. Non di più. Uno solo, ma sufficiente per ammazzare un ragazzo di 16 anni, fermo in bici davanti ad un treno in ripartenza verso nord. Venne trovato solo verso sera, tra la disperazione dei genitori, i fratelli, le sorelle, i cugini, lo zio Erminio. Non ci volle molto a ricostruire l’accaduto. Anche se hai fatto la seconda o terza elementare. E i biglietti rimasti, quei pochi non volati via, erano indiscutibilmente chiari.
Fu quel giorno che Mazzola capì di essere antifascista. Come si potevano portare in Germania i tuoi alleati, senz’acqua, senza mangiare, trattati peggio delle bestie? E i fascisti, le camicie nere dov’erano? Che colpa aveva Ottenio? La curiosità, la voglia di capire, non potevano essere colpe mortali. Ne aveva parlato più volte con padre, nei giorni successivi, quando il dolore si era un poco placato. Ma non ci furono risposte. Non ci potevano essere risposte adeguate all’uccisione di un ragazzo curioso. Andare al lavoro non fu facile in quei giorni. Anche alle Officine Pellizzari il clima non era buono. Si capiva poco e chi capiva stava male. Si respirava tra la polvere della fabbrica, la paura, la diffidenza. Cosa stava succedendo?
Se c’è stato l’armistizio di Badoglio, si vuol fermare la guerra o no? O si è fermata solo da una parte mentre gli altri ti sparano contro. Il clima di settembre o di ottobre era pessimo. Figuriamoci nella nebbia di novembre e dei mesi invernali. Brutti mesi, paura di tutto, senza capirci nulla. In fabbrica si sentivano voci strane, lamentele, discorsi nuovi che prima nessuno aveva avuto il coraggio di tirare fuori. Almeno non prima del 25 luglio.
Dopo la caduta del Duce, anche alle Officine Pellizzari di Arzignano - come in tutte e grandi fabbriche del vicentino – era spontaneamente nato un Comitato clandestino, voglioso di migliorare le condizioni degli operai. Una paga meno da fame, un aumento delle razioni alimentari per la famiglia. Cose importantissime in quel momento quando si tirava avanti tra beni razionati e distribuzione con la tessera annonaria. Ma anche totale cessazione delle violenze contro gli operai. Tutte cose che persino anche Mazzola respirò per bene e toccò per mano. Inevitabilmente.
Aveva iniziato a lavorare lì già nell’estate del ‘40, quando le Officine avevano perso gran parte degli operai chiamati dal Duce alle armi, chi in Grecia, chi in Africa. Con la guerra poi il lavoro non mancava. Ora si costruivano non solo pompe e motori, ma anche parti di mitragliatrici e di altro ‘materiale bellico’ come veniva allora chiamato. Essere operaio delle Officine Pellizzari nei primi anni di guerra era un ‘salvacondotto’ per il regime. Anche tu contribuivi al successo del Duce e alla gloriosa macchina da guerra fascista. E quindi nessuno ti toccava. Poi poco prima dell’8 settembre, qualcosa cambiò. Persino il figlio del titolare, allora ventenne, fece ‘fuoco e fiamme’ per non andare in guerra. Alla fine riuscì a restare a casa, ma in zona qualcuno cominciò a dubitare della fedeltà al Duce della famiglia. E dopo l‘8 settembre qualche alto gerarca del Fascio, se lo ricordò.
C’era un clima di diffidenza reciproca, di paura. Tutto era incerto e non sapevi sempre con chi davvero tu stessi parlando. Fu anche questo che indusse Mazzola ad approfondire, a capire cos’era quel terrore, quella continua diffidenza. A gennaio si sparse la voce che i tedeschi, d’accordo coi gerarchi fascisti locali, volevano trasferire parte della produzione delle Officine Pellizzari in Germania. Non potevano permettere che restasse in Italia, le pompe e i motori erano importanti per la vittoria del Terzo Reich. Meglio averli sotto casa. E ovviamente almeno 4/500 operai sarebbero dovuti andare in Germania assieme agli impianti. Facile capire la situazione.
Chi andava a lavorare da quelle parti non sempre aveva il biglietto di ritorno. Si era ancora alleati qui, non stupidi. Fu così che nel reparto di Mazzola si alimentò, come un fuoco lento, uno spirito antifascista o meglio antinazista. Ammesso che ci fossero differenze.
E fu proprio lì che Mazzola cominciò seriamente a comprendere che era arrivato il momento, malgrado i suoi 18 anni, di rispondere all’assassinio del cugino Ottenio.
Ne parlò più volte col padre. Ma questi lo consigliò di stare calmo, non era detto che tutta la produzione fosse spedita in Germania, non era detto che proprio loro fossero destinati in Germania. Non era contro i ‘capi’ più forti, come Luigi o Cesare, ma non voleva che suo figlio rischiasse la vita. Ma oramai il germe in Mazzola era nato e si stava sviluppando. Decise di non coinvolgere troppo il padre e una sera anziché andare al calcio, come si era convinti a casa, andò a salutare Umberto, il suo caporeparto. Fu in quel momento che capì di essere, in profondità, antifascista ed italiano. Fu in quel momento che cominciò a conoscere anche altri che la pensavano diversamente.
Perché i gerarchi del fascio non facevano niente? A scuola, nelle sfilate, nelle marce ti avevano sempre parlato di Italia, di Patria e ora non facevano assolutamente nulla. Erano come i nazisti, come gli odiati nazisti. Anzi peggio, perché almeno i nazisti lavoravano per il loro paese. I nostri fascisti per chi lavoravano? Per Hitler?
13 settembre 2024 – 81 anni dopo – Rinaldo Battaglia
dal mio ‘Alla sera mangiavamo la neve’ – ed. AliRibelli 2021 -
quando cercavo di spiegare come dalle mie parti i ragazzi diventavano partigiani e antifascisti. Altri tempi.
* Coordinatore della Commissione Storia e Memoria dell'Osservatorio
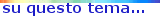 
Dossier
diritti
|
|

