 |
Il linguaggio del silenzio
di
Rinaldo Battaglia *
C’è una frase di Hannah Arendt che andrebbe con frequenza ribadita e ripetuta spesso.
‘Le azioni erano mostruose. Ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso’.
Parlava della Shoah, ma intendeva tutti i crimini che vennero o vengono commessi in guerra, con o senza motivazioni ‘razziali’. Prima, durante e dopo la Shoah. Quando, in termini diversi, regimi che per arrivare al potere - o poi per mantenerlo - facevano o fanno della violenza la loro arma di successo. E noi in Italia col nostro passato fascista non siamo certo esclusi dal tema.
Solitamente quello che fa più male anche dopo la fine di quel regime o di quei regimi, non è il ricordo della violenza usata, il suono delle bombe o i cimiteri pieni di nuove croci, ma soprattutto il silenzio assordante che regna dopo. E quel silenzio uccide ancora. Quel silenzio che viene dopo la violenza e le atrocità passate e che usa il ’linguaggio del silenzio’ per generare altra violenza.
Negando, nascondendo, cancellando dalla memoria le precedenti violenze, preparando la strada ad inevitabili ulteriori violenze. Proprio come avvenuto in precedenza, quando si usava il silenzio sulle teorie razziste, sulle pulizie etniche, sulle violazioni dei diritti umani in modo tale da rendere ‘pressoché normale, né demoniaco né mostruoso’ quel che di mostruoso poi avveniva.
E noi in Italia col nostro passato razzista non siamo certo esclusi dal tema.
Oggi è l’11 giugno, una data come tante, quasi anonima sul calendario. Meno importante, ad esempio, del 10 giugno quando si ricorda il discorso del Duce da Piazzale Venezia nel 1940 che portò l’Italia alla più grande catastrofe militare, economica, sociale e morale mai vissuta. Oppure nel 1924 il sequestro e poi l’uccisione di Giacomo Matteotti, che ufficializzò quanto criminale fosse il regime di Mussolini, vent’anni prima che gli italiani se ne rendessero meglio conto sulla loro pelle.
L’11 giugno di cui – con molto dolore – vi voglio parlare è quello del 1942 ed avvenne nel silenzio della Storia nella zona di Tarnów, più precisamente nelle foreste di Buczyna a Zbylitowska Góra, circa 70 km da Cracovia, in direzione dell’attuale Ucraina.
Quella terra di Polonia era già in mano ai nazisti dal 7 settembre 1939 e in pochi mesi a Tarnów oltre 40 sinagoghe e case di preghiera ebraiche furono fatte saltare in aria e bruciate. Non solo: gli uomini del Fuhrer nel marzo 1941 crearono un ghetto - il ghetto di Tarnów appunto – dove furono deportati ed imprigionati oltre 40.000 ebrei della zona e poi dei territori vicini.
Dal giugno 1942 al 1943 con l’operazione Barbarossa, in cui - mai dimenticarlo - parteciparono tra il silenzio di tutti 229.005 italiani lì spediti dal Duce, tutti gli ebrei dei vari ghetti vennero deportati nei lager di sterminio o massacrati in massa. Solo nella primavera del ’42 e nella zona di Tarnów ne vennero uccisi oltre 10.000. Di questi, solo nella foresta di Buczyna a Zbylitowska Góra, oltre a 6.000 ebrei adulti vi erano 800 bambini.
Chi ha studiato e conosce la Shoah sa che l’eccidio dell’11 giugno 1942 è chiamato dagli storici come il ‘massacro dei bambini’. Senza altre parole, senza date e senza nemmeno identificare il luogo. Perché, quando si massacrano bambini, i cuccioli d’uomo, non ha senso dire dove e quando. Sono crimini mostruosi e ogni crimine rappresenta altri crimini analoghi e mostruosi.
Jean-Paul Sartre diceva che ‘il fascismo (e il nazismo, che è la stessa cosa) non è definito dal numero delle sue vittime, ma dal modo con cui le uccide’.
E qui nella foresta di Buczyna a Zbylitowska Góra non conta solo il numero dei bambini uccisi, ma soprattutto conoscerne il modo.
Gran parte degli 800 bambini sono stati massacrati a legnate o a colpi d’ascia. Erano bambini di razza inferiore, non degni di vivere e non degni nemmeno di morire con una pallottola, perché sarebbe stato un costo inutile. Uccisi a sangue vivo nel silenzio di una foresta di faggi.
Quel giorno, il giorno del ‘massacro dei bambini’, all’alba il comandante della polizia penale delle SS Paul F. Klee, aveva fatto consegnare due razioni di alcool ad ogni soldato. Doppia razione.
E così armati di asce, le S.S. sfondarono tutte le porte chiuse di tutte le abitazioni del ghetto di Tarnow e almeno 3.000 persone vennero subito assassinate. Chi riuscì a scappare dalle case venne ucciso sulle scale, per strada, dove si trovava. Tutti gli ebrei poi trovati senza documenti vennero uccisi sul posto.
Molti altri, soprattutto i vecchi e malati, spinti contro la recinzione del cimitero ebraico o lì portati anche a mezzo camion, spogliati e fucilati. Spogliati perché anche i loro vestiti, usati e consumati, potevano essere riciclati.
I rimanenti, essenzialmente donne coi i loro bambini e anziani, vennero spinti nella foresta di Zbylitowska Gora. Qui i bambini, separati con forza dalle madri e gli altri per lo più già orfani, neonati e più grandi fino a circa 8 anni, massacrati senza pietà e abbandonati in 6 grandi fosse comuni, già fatte preparare nella foresta. Massacrati e abbandonati come spazzatura, come letame per le piante della foresta.
Quando sentite parlare di razzismo, di pulizie etniche, di purezza della razza italiana, ricordatevi che questi discorsi erano molto in voga ad inizio 1900, ben prima che nascesse il fascismo del Duce o il nazismo del Fuhrer. In Francia, pioniere di questo era Maurice Auguste Barrès, padre non a caso del ‘nazionalismo francese repubblicano’.
Barrès, ancora prima della Grande Guerra, parlava di “grand remplacement” sostenendo che «una nuova popolazione avrebbe invaso la Francia e preso il potere mandando in rovina la patria.»
Parlava e sosteneva tra il silenzio di tutti, perché forse a molti quelle parole andavano bene in quanto considerate a difesa dei loro privilegi economici e sociali. In Italia, poi in Germania e a macchia d’olio nell’Europa governate o occupate dal nazifascismo, quelle parole attaccheranno in fretta.
Quando sentite parlare di razzismo, di pulizie etniche, di purezza della razza italiana, ricordiamoci tutti della foresta di Buczyna a Zbylitowska Góra, dell’11 giugno 1942 e dei bambini lì massacrati in ricordo di tutti gli altri martiri innocenti.
Ricordiamoci e parliamone forte, perché che fa più male non è il ricordo della violenza usata, il suono delle bombe o i cimiteri pieni di nuove croci, ma soprattutto il silenzio assordante che regna su quei massacri.
E quel silenzio ancora oggi uccide. Senza nemmeno portare il pensiero al destino dei bambini, oggi, rubati dalle loro case in Ucraina o nei kibbutz israeliani o, peggio ancora, nelle tendopoli di Gaza. Senza nemmeno guardarsi negli altri angoli del mondo, senza nemmeno far fatica di analizzare il mondo.
Purtroppo, l’11 giugno 1942 non finisce mai. Tra il silenzio assordante del mondo civile e il suo colpevole linguaggio moderno, quello che lascia fare come nulla fosse, come fosse una normale abitudine. Il linguaggio del silenzio, il linguaggio dell’indifferenza.
11 giugno 2024 – 82 anni dopo
* Coordinatore della Commissione Storia e Memoria dell'Osservatorio
VAI A TUTTE LE NOTIZIE SU GAZA
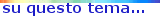 
Dossier
diritti
|
|

