 |
Il fronte di Stresa
di
Rinaldo Battaglia *
“Nessun fiocco di neve, in una valanga, si sente mai responsabile della valanga che ha provocato”.
E’ una frase di Stanisław Jerzy Lec, che forse - si dice - l’autore polacco l’abbia preso da Voltaire o persino da una battuta del comico George Burns.
Nessun fiocco di neve si sente responsabile, forse perché nessuno lo ha prima fermato quando si poteva, sebbene alla fine, diventando valanga, abbia poi distrutto, ucciso, rovinato tutto. Più volte studiando l’ultima guerra mondiale o la figura criminale di Hitler questa frase mi è venuta a mente e, ancora peggio, la domanda conseguente: si poteva fermare per tempo Hitler? e se sì, perché non lo si è fatto?
Oggi è l’11 aprile e quasi 90 anni fa – l’11 aprile 1935 per la precisione - sul lago Maggiore, presso il Palazzo Borromeo sull'Isola Bella, iniziò un’importantissima riunione, passata alla Storia come “la conferenza di Stresa”o meglio ‘il fronte di Stresa’. Durò 4 giorni e, quando il giorno 14 si chiuse, risultò chiaramente come un sonoro fallimento, anche se tutti i partecipanti non vollero o poterono ammetterlo. Ma sarà il tempo a confermarlo, senza ombra di dubbio.
Ufficialmente fu venduta all’esterno come una grande vittoria della diplomazia e della politica. In quei 4 giorni i tre vincitori europei della Grande Guerra, finita solo 17 anni prima, quali la Gran Bretagna (presente il primo ministro Ramsay MacDonald), la Francia (rappresentata dal ministro degli esteri francese, poi promosso capo del governo, Pierre Laval) e la nostra Italia, con Benito Mussolini a farla da padrone di casa, definirono come comportarsi nei riguardi di Hitler e del suo nuovo corso nazista.
Hitler era diventato il Fuhrer da solo 2 anni ma già preoccupava – e non poco – chi non voleva assolutamente tornare indietro al tempo della Somme, di Verdun o delle mille battaglie del Carso. Almeno i primi due, in quanto paesi democratici e dove il consenso per governare passava dal voto effettivamente popolare e per poter vincere ci si doveva assolutamente dichiararsi contrari a qualsiasi futura guerra. Chi non lo annunciava pubblicamente e apertamente non avrebbe avuto alcun successo. Diverso il caso dell’Italia, da 13 anni schiava del Duce, con elezioni false e ridicole, dove nell’ultima tornata elettorale – la farsa del 25 marzo 1934 – il fascismo venne votato al 99,85%. E il Duce non aveva mai negato la sua voglia di tornare alla guerra o meglio di mandare gli italiani al fronte, a combattere a suo nome e nel suo esclusivo interesse. Solo pochi mesi prima, il 24 agosto 1934, senza creare malintesi, nella caserma Tre Poggioli aveva, in piedi su un carro armato, gridato che “La Nazione deve essere pronta alla guerra non domani, ma oggi.” Parole di fuoco, miccia accesa per attivare un incendio a breve.
Il fronte di Stresa aveva lo scopo di trovare una strategia europea comune, in funzione anti-tedesca, dopo che il 16 marzo 1935, neanche un mese prima, Hitler aveva ufficialmente dichiarato l'intenzione di ricostruire in Germania una forza aerea, di incrementare le dimensioni del suo esercito a 36 divisioni (500.000 uomini) e coerentemente di reintrodurre la coscrizione obbligatoria, ossia – in altre parole – di crearsi un vero e proprio esercito pronto alla nuova guerra di rivincita, dopo l’umiliante sconfitta del 1918. E tutto questo in chiara ed evidente violazione del Trattato di Versailles del giugno 1919, che aveva proibito alla Germania non solo la creazione di un'aviazione militare e la coscrizione obbligatoria, ma di limitare soprattutto la forza dell’esercito tedesco a non più di soli 100.000 uomini.
Dopo 4 giorni, i tre statisti se ne tornarono a casa con un sacco di belle parole, ma in sostanza su altri temi. Si trovò l’accordo sul fatto che l’Austria doveva rimanere indipendente (prevedendo già quello che Hitler avrebbe fatto solo 3 anni dopo) e che Gran Bretagna, Francia ed Italia sarebbero all’occorrenza state “pronte a reagire ad ogni futuro tentativo da parte della Germania di modificare o violare il Trattato di Versailles”. In che modo fosse, però, non venne deciso o definito né precisato. Qualcuno, altrove, avrebbe riassunto il tutto in altre parole: ‘solo chiacchiere e distintivo’.
Nessuno dei tre paesi vincitori, né Francia, né Gran Bretagna, né Italia considerò per un attimo l’ipotesi di invadere (o di minacciare seriamente di invadere) la Germania, probabilmente l'unico sistema valido per fermare il riarmo tedesco e non permettere così all’esercito di Hitler di invadere altri paesi, come avverrà presto. Il 7 marzo 1936 toccherà alla Renania (dopo Versailles totalmente smilitarizzata, a difesa del Belgio), il 13 marzo 1938 l’Anschluss con l’annessione armata dell’Austria, il 30 settembre 1938 i Sudeti (oggi diciamo quasi l’intera Slovacchia), il 22 marzo 1939 il territorio di Memel allora Lituania. Senza dimenticare che già il 1 marzo 1935 Hitler si era ripreso la Saar, dal 1919 passata alla Francia.
In altre parole, dopo ‘il fronte di Stresa’, anziché fermarsi, Hitler mise la quarta marcia se non la quinta.
Se non fu un fallimento cosa fu, quindi, quella conferenza?
Ma i veri motivi del fallimento si scopriranno negli anni successivi. Sarà il tempo, solo il tempo, a definirli alla luce del sole. E molti capiranno.
Partiamo dalla Gran Bretagna e dal suo premier Ramsay MacDonald. Molto debole e stanco, oramai ai titoli di coda e non a caso, neanche due mesi dopo (7 giugno 1935), lasciò il comando del governo e peraltro nelle successive elezioni del novembre 1935 perse anche il seggio parlamentare, non riuscendo nemmeno ad esser rieletto come semplice deputato (morirà due anni dopo nel novembre 1937). Chi lo sostituirà al governo (Stanley Baldwin) punterà, più che ad operare in sinergia coi francesi e fare un fronte unito in Europa, essenzialmente a cercare un accordo (anche economico) con i tedeschi che salvasse la pace o almeno rimandasse la guerra, oltre a guadagnarci qualcosa a discapito degli altri. Lo stesso farà il successore Neville Chamberlain a fine maggio del ’37.
Irriverente, o forse meglio ridicolo, fu proprio l’accordo economico tra Gran Bretagna e Germania, immediatamente successivo a Stresa (il 18 giugno 1935, solo due mesi dopo) dove Hitler ottenne che alla Germania fosse consentito di possedere una flotta da guerra (purché questa non avesse superato il 35% di quella britannica, senza tener conto di Francia ed Italia) e di costruire sottomarini, che saranno la fonte primaria di migliaia di morti inglesi nella guerra marina dopo l’inverno del ‘39. Il governo di Londra, in cambio, ebbe la garanzia che l’Inghilterra non sarebbe stata attaccata e che i ‘fornitori inglesi’ sarebbero stati privilegiati ora che Germania necessitava di tutto ed in particolare delle materie prime gestite dalla Gran Bretagna e dalle sue ricche colonie. Fu talmente irriverente e ridicolo l’accordo che Londra non si preoccupò nemmeno d'informare la Francia e l’Italia di quanto deciso il 18 giugno col ‘nemico’ nazista.
Peggio o non meglio la Francia, a Stresa guidata da Pierre Laval. Se da una parte Laval puntava su una politica che mantenesse in vita l’ordine europeo stabilito a Versailles escludendo qualsiasi guerra contro chiunque per non perdere consensi, dall’altra parte sotto sotto ammirava il ‘modus operandi’ del Fuhrer: forte, deciso, sicuro di sé, grande nemico dei ‘social-comunisti’ come Laval definiva i suoi oppositori, sempre troppo disponibili verso le classi meno abbienti e operaie. Non sarà un caso, ma dopo la disfatta francese del giugno 1940, sarà col m.llo Philippe Pétain l’uomo forte del regime fascista e collaborazionista di Vichy. Finirà condannato a morte dai francesi e fucilato quale traditore della patria il 15 ottobre 1945. Hitler, per oltre 4 anni il suo padrone e socio, si era suicidato solo 6 mesi prima.
E poi il nostro Duce, colui che doveva garantire il rispetto dei patti di Versailles sia nella protezione della Renania che dell’Austria, come sanzionato anche nel Patto di Locarno, successivo a Versailles. Tutte passate in fretta alla Germania, senza che alzasse un dito. Il nostro Duce, colui che non vedeva l’ora di muoversi in autonomia, anche contro gli interessi della Francia e della Gran Bretagna all’occorrenza, per i suoi sogni di gloria. Non passeranno neanche 6 mesi dalla conferenza di Stresa, che il 3 ottobre ordinerà al generale Emilio De Bono di attaccare a tradimento l’Abissinia e sottomettere l’Etiopia, Stato allora sovrano ed indipendente oltrechè confinante con le colonie francesi ed inglesi del Corno d’Africa. Mussolini, firmando a Stresa il documento del ‘fronte comune’ con Francia e Gran Bretagna, si era convinto che le due altre potenze non sarebbero intervenute contro la sua conquista di Adis Abeba. E così avvenne. E con l’invasione fascista dell’Abissinia e le conseguenti imposizioni di sanzioni economiche all'Italia – quale conseguenza delle regole previste dalla Società delle Nazioni – il ‘fronte di Stresa’ franò solo dopo 6 mesi di vita. Peggio di così cosa si vuole?
Passerà un anno dall’invasione dell’Abissinia ed ecco il 23 ottobre 1936 il primo matrimonio di Mussolini con Hitler. Lo chiameranno ‘Asse Roma-Berlino’, propedeutico al ’Patto d’Acciaio’ del 22 maggio 1939 , quello che aprirà in pompa magna la porta alla Seconda Guerra Mondiale. Poteva quindi il Duce a Stresa decidere o convincere gli altri a far qualcosa per fermare Hitler e il riarmo della Germania?
Nessuna sorpresa, quindi, se durante la conferenza non si fece nessun riferimento, né effettivo né ufficiale, alla Germania. E questo a causa dell’ ambiguità – per vari motivi - adottata dai tre leader.
Se non fu un ‘fallimento pilotato’ cos’è stato?
Ovvio che pochi – soprattutto in Italia, foriera di ignoranza storica sugli anni del fascismo - pochi conoscano la conferenza di Stresa, con disprezzo o ironia chiamata da molti, da allora, ‘il fronte di Stresa’. Fronte ‘sfrontato’ dove ognuno dei tre soci pensava a bidonare – la mia educazione classica non mi permette di usare termini più scurrili – gli altri due. Nell’interesse del quarto socio, non presente fisicamente ma beneficiario di tutto.
“Nessun fiocco di neve, in una valanga, si sente mai responsabile della valanga che ha provocato”.
Ma forse più che la frase di Stanisław Jerzy Lec, per restare sul tema, risulta più opportuna una del grande Emil Cioran dove diceva che “fallimento chiama fallimento. E’ una legge che verifico ogni giorno a mie spese. Ogni sconfitta ha un effetto valanga”.
E quella valanga noi sappiamo bene quanto sia costata solo di vite umane.
11 aprile 2024 – 89 anni dopo - Rinaldo Battaglia
* Coordinatore della Commissione Storia e Memoria dell'Osservatorio
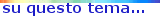 
Dossier
diritti
|
|

